
![]()
"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI)
"La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)
|
"Il patrimonio greco, criticamente purificato, è parte integrante della fede cristiana" (Benedetto XVI) "La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma" (Benedetto XVI)
|
|
| |
I Greci in India
di Moreno Morani
(Zetesis, 2008-1)
NB. Per passare dal testo alla nota e viceversa, doppio clic sul numero di riferimento.
I. Profilo storico.
1. Alessandro Magno
Le ragioni che convinsero Alessandro a non proseguire il suo ambizioso disegno di conquista dell’India sono esposte con chiarezza dalle fonti antiche: Alessandro dovette rinunciare perché ormai il suo esercito era troppo stanco e privo di mezzi per continuare oltre in questa impresa. Curzio Rufo tratteggia con enfasi drammatica la sensazione di incomprensione e addirittura di aperta conflittualità che si era instaurata tra il re macedone e le truppe. Queste non osano sollevarsi apertamente a un sovrano che temono e da cui obiettivamente avevano ottenuto favori e ricchezze: è un atteggiamento di rassegnazione più o meno velata, incapace di esprimersi in tutta la sua interezza, ma pericoloso, perché a lungo andare impedisce la collaborazione tra comandante e soldati. Nella scena che si svolge al passaggio dell’Ifasi (IX 2 s.) predomina la tensione e l’esaltazione emotiva. Di fronte ad Alessandro che, più che ordinare, quasi scongiura, in nome del loro valore, i soldati di seguirlo nella nuova impresa, non come capo ma come loro amico e commilitone (IX 2, 28), questi tacciono tenendo lo sguardo rivolto verso terra, tanto da provocare al re una risposta che, nella deliberata accentuazione del tono patetico, sembra lontana dal suo stile e dal suo usuale modo di esprimersi e di comportarsi (ibid. 31-34):
Cumque illi in terram demissis capitibus tacere perseverarent: ‘Nescio quid’, inquit, ‘in vos inprudens deliqui, quod me ne intueri quidem vultis. In solitudine mihi videor esse. Nemo respondet, nemo saltem negat. Quos adloquor? quid autem postulo? Vestram gloriam et magnitudinem vindicamus. Ubi sunt illi, quorum certamen paulo ante vidi contendentium, qui potissimum vulnerati regis corpus exciperent? Desertus, destitutus sum, hostibus deditus. (...) Mori praestat quam precario imperatorem esse. Ite reduces domos! ite deserto rege ovantes! Ego hic aut vobis desperatae victoriae aut honestae morti locum inveniam’.
 All’accorato discorso di Ceno, che a nome
dei soldati chiedeva di evitare alla truppa stanca e provata
un’ulteriore fatica e che aveva provocato nell’assemblea una scena
quasi isterica (“clamor undique cum ploratu oritur regem, patrem,
dominum confusis appellantibus vocibus ... universa contione effusius
flente”), Alessandro replica con un gesto di grande irritazione: si
isola nella sua tenda proibendo a chiunque di venire a cercarlo, e solo
dopo due giorni
[1] abbandona il progetto di
un’avanzata per terra, per accogliere l’idea suggerita da Ceno di
procedere verso l’Oceano seguendo il corso del fiume fino alla foce
dell’Indo. Alla decisione di Alessandro, che sognava di estendere il
suo dominio fino agli estremi confini del mondo e di dare celebrità a
regioni finora sconosciute (“Dabo nobilitatem ignobilibus locis,
aperiam cunctis gentibus terras, quas natura longe submoverat” IX 6,
22), contribuiscono però anche altri fattori. Per quanto la campagna
militare all’inizio non facesse presagire difficoltà insormontabili (in
molti villaggi la popolazione fugge davanti a lui o esce spontaneamente
a rendergli omaggio), col procedere del tempo la resistenza delle
popolazioni locali si era fatta più rigida, e Alessandro aveva dovuto
aprirsi la strada nella valle dell’Indo con
difficoltà crescente.
Alla fine aveva dovuto rendersi conto del fatto che il terreno che si
apriva davanti a lui era ben più sconfinato di quanto avesse previsto,
e che molte delle supposizioni che erano alla base del suo progetto si
erano rivelate fallaci: aveva pensato
[2] che procedendo per quella
via sarebbe arrivato in Africa, alle sorgenti del Nilo (tanto nel Nilo
che nell’Indo vivono i coccodrilli, e questo aveva indotto a confondere
tra loro i due fiumi, e oltretutto anche la vegetazione dell’India
ricordava quella dell’Egitto), e ora si accorgeva che le cose non
stavano in questi termini. La campagna aveva bisogno di una
preparazione più accurata e di un apporto di truppe fresche: oltre
tutto, c’era la concreta possibilità che, approfittando del prolungarsi
della sua assenza, si verificassero moti di ribellione o di sedizione
alle sue spalle. Alessandro aveva esteso la sua conquista fino al fiume
Ipasi e aveva fondato alcune città (tra cui Alessandria Bucefala,
l’odierna Jehlum nel Punjab; Alessandria nel Caucaso, l’odierna Bagram,
nell’Hindu-Kush, e altre) e aveva lasciato l’amministrazione del
territorio a Poro e Taxila. Desideroso di sapere di più dell’India e
della sua cultura, aveva mandato Nearco e Onesicrito a circumnavigare
le coste di quelle regioni sconosciute e altri suoi delegati a
raccogliere informazioni sulla geografia, la storia, le tradizioni
dell’India
[3], e si favoleggiò anche di
suoi incontri e di suoi rapporti coi sapienti dell’India, i gimnosofisti
[4], e, a detta di Strabone, questo incontro
lasciò più di una traccia sul suo pensiero
[5]. La sua decisione di
rinunciare all’impresa era probabilmente solo temporanea (prima di
ritirarsi aveva fatto costruire dodici altari di pietre squadrate alte
come torri, per segnare, a testimonianza dei posteri, l’estrema punta
est della sua avanzata), ma nel volgere di pochi mesi sopraggiunse
improvvisa la malattia e poi la morte
[6].
All’accorato discorso di Ceno, che a nome
dei soldati chiedeva di evitare alla truppa stanca e provata
un’ulteriore fatica e che aveva provocato nell’assemblea una scena
quasi isterica (“clamor undique cum ploratu oritur regem, patrem,
dominum confusis appellantibus vocibus ... universa contione effusius
flente”), Alessandro replica con un gesto di grande irritazione: si
isola nella sua tenda proibendo a chiunque di venire a cercarlo, e solo
dopo due giorni
[1] abbandona il progetto di
un’avanzata per terra, per accogliere l’idea suggerita da Ceno di
procedere verso l’Oceano seguendo il corso del fiume fino alla foce
dell’Indo. Alla decisione di Alessandro, che sognava di estendere il
suo dominio fino agli estremi confini del mondo e di dare celebrità a
regioni finora sconosciute (“Dabo nobilitatem ignobilibus locis,
aperiam cunctis gentibus terras, quas natura longe submoverat” IX 6,
22), contribuiscono però anche altri fattori. Per quanto la campagna
militare all’inizio non facesse presagire difficoltà insormontabili (in
molti villaggi la popolazione fugge davanti a lui o esce spontaneamente
a rendergli omaggio), col procedere del tempo la resistenza delle
popolazioni locali si era fatta più rigida, e Alessandro aveva dovuto
aprirsi la strada nella valle dell’Indo con
difficoltà crescente.
Alla fine aveva dovuto rendersi conto del fatto che il terreno che si
apriva davanti a lui era ben più sconfinato di quanto avesse previsto,
e che molte delle supposizioni che erano alla base del suo progetto si
erano rivelate fallaci: aveva pensato
[2] che procedendo per quella
via sarebbe arrivato in Africa, alle sorgenti del Nilo (tanto nel Nilo
che nell’Indo vivono i coccodrilli, e questo aveva indotto a confondere
tra loro i due fiumi, e oltretutto anche la vegetazione dell’India
ricordava quella dell’Egitto), e ora si accorgeva che le cose non
stavano in questi termini. La campagna aveva bisogno di una
preparazione più accurata e di un apporto di truppe fresche: oltre
tutto, c’era la concreta possibilità che, approfittando del prolungarsi
della sua assenza, si verificassero moti di ribellione o di sedizione
alle sue spalle. Alessandro aveva esteso la sua conquista fino al fiume
Ipasi e aveva fondato alcune città (tra cui Alessandria Bucefala,
l’odierna Jehlum nel Punjab; Alessandria nel Caucaso, l’odierna Bagram,
nell’Hindu-Kush, e altre) e aveva lasciato l’amministrazione del
territorio a Poro e Taxila. Desideroso di sapere di più dell’India e
della sua cultura, aveva mandato Nearco e Onesicrito a circumnavigare
le coste di quelle regioni sconosciute e altri suoi delegati a
raccogliere informazioni sulla geografia, la storia, le tradizioni
dell’India
[3], e si favoleggiò anche di
suoi incontri e di suoi rapporti coi sapienti dell’India, i gimnosofisti
[4], e, a detta di Strabone, questo incontro
lasciò più di una traccia sul suo pensiero
[5]. La sua decisione di
rinunciare all’impresa era probabilmente solo temporanea (prima di
ritirarsi aveva fatto costruire dodici altari di pietre squadrate alte
come torri, per segnare, a testimonianza dei posteri, l’estrema punta
est della sua avanzata), ma nel volgere di pochi mesi sopraggiunse
improvvisa la malattia e poi la morte
[6].
In quanto erede dell’impero Achemenide, Alessandro veniva a possedere anche un lembo dell’India nord-occidentale, assoggettata e organizzata in satrapia da Dario I [7]. I Persiani si erano affacciati ai confini dell’India, e si erano impadroniti di parte dell’area del Sindh (approfittando anche delle guerre e delle divisioni dei signori della zona) attorno al 518, in un secolo cruciale della storia e della cultura indiana, quando fanno la loro apparizione le due grandi religioni eterodosse dell’India, il buddhismo e il jainismo, che iniziano a diffondersi a spese della cultura fino allora dominante, quella che seguiva la linea tradizionale vedico-brahmanica. La conquista persiana permetteva all’India di aprirsi a un mondo occidentale fin allora sconosciuto. Con l’avventura di Alessandro Magno, confinanti dell’India sono ora il mondo e la cultura greco-ellenistica, non più i persiani. Questa sostituzione avrà riflessi importanti dall’una come dall’altra parte della frontiera.
Indubbiamente l’interesse dei Greci nei confronti dell’India non nasce con Alessandro Magno [8]. L’India era per i Greci una terra posta agli estremi confini del mondo, una terra inaccessibile e dimenticata, una terra abitata da genti di cui si sa poco o nulla (e quel poco che si sapeva era così straordinario da invogliare a saperne di più), eppure il desiderio di spingersi fino in queste zone e di esportare anche qui la cultura greca è fortemente radicato nell’immaginario collettivo dei Greci, e si esprime nel racconto mitico di Dioniso, che avrebbe fatto irruzione fino in India sottomettendola. A questa incursione di Dioniso in India accenna, in tono critico, Arriano [9], chiedendosi quanto sia compatibile la raffigurazione usuale e prevalentemente pacifica di Dioniso con questa immagine di dio guerriero, che non avrebbe sottomesso altra popolazione se non l’India. Durante il viaggio sia di andata sia di ritorno il dio avrebbe dovuto affrontare pericoli e sconfiggere numerosi nemici (tra cui le Amazoni, che avevano tentato di contrastarlo). Anche di Eracle si narrava che avesse compiuto grandi gesta in India, e uno dei motivi che avevano indotto Alessandro a spingere il più possibile a oriente la sua avanzata era proprio il vanto di avere oltrepassato i limiti verso i quali si erano avventurati personaggi grandi e prediletti come Dioniso ed Eracle.
Questi racconti mitici s’intrecciano però con una precisa realtà storica, la presenza di minoranze greche in queste terre lontane anche prima della venuta di Alessandro. Se quello di Dioniso è un mito, realtà storica è invece l’esistenza di Nisa, una città situata tra i fiumi Cophen e Indo e abitata da Greci. Il nome, come è evidente, è allusivo al mito di Dioniso, dal momento che Nisa era il nome della nutrice del dio: secondo gli abitanti, Dioniso stesso aveva fondato la città, e da quel momento essa si era mantenuta libera e ben governata, e i suoi abitanti autonomi [10]. Nonostante qualche incertezza e contraddizione, l’esistenza di questa città non può essere messa in dubbio. Fondata forse da mercenari greci che avevano seguito Dario in una delle sue spedizioni, la città accoglie benevolmente Alessandro, che viene anche accompagnato a visitare il territorio circostante, dove si conservavano lontani ricordi della venuta di Dioniso [11]. Ben diverso destino era toccato a un’altra minoranza greca, quelle dei Branchidi. Questi si vantavano di essere i discendenti di Branco, il mitico fondatore di un tempio di Apollo nei pressi di Mileto. Al tempo della spedizione di Serse i loro antenati avevano consegnato sé stessi e il tesoro del tempio al re persiano, rendendosi così invisi a tutti gli altri Greci. Dopo la sconfitta di Serse, il re persiano, mostrando una moderazione e un senso umanitario maggiore di quello dimostrato in circostanze analoghe dagli Alleati dopo la fine della seconda guerra mondiale, li aveva salvati da una sicura e sanguinosa vendetta portandoli con sé durante la sua ritirata e assegnando loro un villaggio in Sogdiana. Quando Alessandro li incontrò, era già in uno stadio avanzato il processo di assimilazione ai Persiani, anche in grazia dei molti matrimoni misti, ma non era venuta meno né la coscienza della loro origine né la conoscenza della lingua greca. Il loro destino però fu ben diverso da quello dei Niseni: fattosi accogliere in città, Alessandro diede corso a una carneficina che coinvolse praticamente tutta la popolazione, e la città stessa fu distrutta: un eccidio che gli valse la riprovazione anche di storici apertamente benevoli nei suoi confronti, come Plutarco [12].
2. Il regno di Battria.
Con l’intento di lasciare persone fidate alla guida delle province lontane, spesso inquiete (Besso, dopo avere ucciso Dario III, aveva tentato di organizzare un movimento di resistenza nazionale nella sua satrapia battriana), Alessandro aveva lasciato la guida della Battria e della Sogdiana a un generale di provenienza macedone, Filippo. Poco tempo dopo la sua morte, quando la spartizione dell’impero da lui conquistato fu ratificata col Trattato di Triparadiso (321 a.C.), Filippo fu trasferito in Partia, e signore di Battria e Sogdiana, dal momento che nessun macedone intendeva assumere il comando delle regioni più lontane [13], divenne Stasanore di Soli [14], uno straniero cipriota, che però, essendo stato un fedele seguace di Alessandro ed essendosi distinto nelle operazioni svolte in Battriana, già conosceva i problemi del territorio. Delle satrapie indiane furono nominati governatori i re locali Poro e Taxile, mentre al comando delle truppe di stanza nella regione fu nominato un generale greco di nome Eudemo. Poco sappiamo del regno di Stasanore, che dovette comunque incontrare il favore delle popolazioni locali. Non conosciamo la data esatta della sua morte, e forse era già morto quando, nel 312, Seleuco Nicatore, dopo avere riconquistato Babilonia, aveva rivendicato il possesso, in quanto successore di Alessandro, di tutta l’Asia. La sostanziale indisponibilità delle regioni orientali a riconoscere la sovranità di Seleuco era dovuta non soltanto o non tanto a una scarsa simpatia delle popolazioni locali, quanto soprattutto alla forte presenza nelle colonie lasciate da Alessandro e nei quadri del governo di Greci, poco propensi a farsi comandare da un signore macedone. Seleuco doveva procedere a una vera e propria riconquista della regione, e la lotta fu così dura, che egli dovette delegare a suo figlio Antioco il compito di domare quelle terre lontane.
Mentre si svolgevano queste lotte tra i Diadochi, dall’altra parte della collina si stava profilando un evento di portata rilevante. L’India, divisa fin allora in una varietà di entità politiche, veniva progressivamente unificata sotto la spinta espansionistica della dinastia Nanda, che, partendo dal Magadha (nel Nord-Est dell’India), aveva assoggettato buona parte dell’India settentrionale e la governava in modo dispotico. Nel 322, non sappiamo precisamente in quali circostanze, ma certamente in seguito a una sollevazione, la dinastia Nanda veniva sostituita dalla dinastia Maurya. Il primo sovrano della nuova dinastia, Candragupta (Σανδράκοττος o Σανδρόκοττος nelle fonti greche) [15], un sovrano valoroso e capace, continua l’opera dei Nanda, e giunge alla quasi completa unificazione di tutta l’India. Alle vicende che portarono alla sostituzione dei Nanda con la nuova dinastia sembra che non siano stati del tutto estranei anche i Greci, dal momento che le fonti indiane (e in particolare il Mūdrarākėasa), nell’enumerazione delle popolazioni straniere che avevano appoggiato Candragupta, indicano anche gli yavana [16], e viene nominato, tra i sovrani amici, anche un Parvata, che è la usuale denominazione indiana di quel Poro che era stato lasciato da Alessandro a presidiare i lembi orientali dell’impero, carica che, a quanto sembra, gli era stata poi riconfermata dal Trattato di Triparadiso.
Sulle circostanze che portarono alla sostituzione dei Nanda coi Maurya abbiamo fonti storiche (non sempre affidabili) soprattutto di parte greca. La principale fonte indiana è costituita dal dramma di argomento storico Mudrārākėasa, del poeta Viśakhadatta, che è tardo (tra il VII e il IX secolo [17]), ma può rifarsi a racconti o tradizioni contemporanee agli avvenimenti. Trattandosi di un dramma, e non di un resoconto storico, è difficile discernere l’elemento propriamente storico dalle aggiunte drammatiche.
Il dramma in sette atti Mudrārākṣasa (‘Rākṣasa del sigillo’, cioè sconfitto per mezzo del sigillo) ha una collocazione un po’ sui generis nel panorama del teatro indiano. Si tratta di un dramma d’argomento politico. Protagonisti sono da una parte Caṇakya, l’abile ministro di Candragupta (che appare in alcuni passi, ma con un ruolo tutto sommato marginale), dall’altra Rākṣasa, il primo ministro del re Nanda ormai deposto, che è rimasto fedele a lui e che si è rifugiato all’estero, presso il re straniero Malayaketu; questi vorrebbe vendicare il padre, che è stato defraudato della parte di regno che gli era stata promessa e che è stato ucciso per mezzo di una ragazza avvelenatrice [18]. Caṇakya, figura pressoché leggendaria del pensiero politico indiano (è stato trasmesso sotto il suo nome anche un trattato di politica), è stato personalmente offeso dai Nanda e ha giurato eterna inimicizia al deposto sovrano e a tutti i suoi sostenitori: ha sciolto i capelli in segno di ira e ha promesso con sé stesso che avrebbe nuovamente legato la sua chioma solamente quando la sua collera sarebbe stata placata dalla fine della sua vendetta. Sarebbe difficile raccontare in modo riassuntivo i vari espedienti e stratagemmi che Caṇakya mette in atto per raggiungere il suo scopo: sono al suo servizio un gran numero di spie infiltrate nel campo di Rākṣasa, con una varietà di tipi umani, che vanno dal mendicante jaina all’incantatore di serpenti: questi agiscono ognuno all’insaputa dell’altro, senza conoscersi tra di loro, dando luogo a situazioni complesse, in cui non sempre è agevole per il lettore o lo spettatore seguire il filo degli avvenimenti e capire a che cosa mira la singola azione di Caṇakya. Alla fine questi raggiunge il suo scopo, che è quello di creare divisione tra Rākṣasa e il suo alleato e di convincere lo stesso Rākṣasa a cambiare campo, passando dalla parte dei Maurya. Per fare questo si serve di un sigillo (mudrā), che è venuto casualmente nelle mani di una delle sue spie: nel momento in cui aveva lasciato PaĘaliputra per raggiungere Malayaketu, il ministro aveva affidato sua moglie e la sua famiglia all’amico Candanadāsa, potente capo della corporazione dei gioiellieri. Il sigillo col nome del ministro era caduto a terra dalle mani smagrite della donna ed era stato raccolto da una delle spie di Caṇakya, che se ne era servito sia per fare imprigionare Candanadāsa, minacciando di condannarlo a morte per tradimento (in quanto aveva nascosto e dato rifugio alla famiglia di un traditore), sia per scrivere una lettera contraffatta, che, letta alla presenza di Malayaketu, faceva pensare a un raggiro che Rākṣasa stava ordendo ai danni dell’alleato. Alla fine del dramma il tentativo di invasione di Malayaketu viene sventato e Rākṣasa, cacciato da Malayaketu e ormai sconfitto, accetta di passare dalla parte dell’avversario anche per evitare all’amico Candanadāsa l’esecuzione capitale che era stata ormai approntata. Il dramma di Viśakhadatta, come si è detto, è un prodotto anomalo: il consueto intreccio di natura amorosa è sostituito da un complesso e spesso intricato gioco di sotterfugi reciproci: a questa oscurità e complessità si adegua anche lo stile del dramma, la cui lingua inserisce praticamente a ogni passo allusioni sofisticate, con possibilità di duplice lettura di parole e interi passaggi. Il lettore può essere disorientato dalle molte sottigliezze stilistiche e lessicali, e il continuo riferimento alle arti e alle astuzie della politica, che richiama spesso argomenti di trattati e di dottrine ormai consolidate [19], non contribuisce certo né a rendere più agevole l’approccio dello spettatore comune né a risollevare il tono complessivo del dramma. Anche lo spazio delle strofe liriche (anch’esse appesantite e rese oscure dalle allusioni e dalle duplicità di lettura di cui si è detto) è nel complesso modesto, rispetto alla lunghezza delle parti prosastiche, in cui un’analisi persino minuziosa degli avvenimenti che si stanno svolgendo e le spiegazioni, necessariamente particolareggiate, dei fini che si intendono perseguire spesso rallenta il procedere dell’azione del dramma. Ciò nonostante, non mancano pagine di vera poesia. Molto felice è la caratterizzazione sia dei due personaggi fondamentali sia di alcuni personaggi minori, che fanno da contorno nel gioco di raggiri in cui ciascuno agisce quasi sempre all’insaputa degli altri, e poeticamente notevole è la scena all’inizio del sesto atto in cui Rākṣasa, ormai certo della propria sconfitta e della necessità di venire a patti con l’avversario, rientrato nella capitale di Candragupta, si sofferma, in un lungo monologo, a meditare sulla propria infelice vicenda, dando libero sfogo alla propria nostalgia per la vista di tante cose che gli suscitano tristi reminiscenze di situazioni e persone che ormai non ci sono più. Per quanto ognuno dei due sia disponibile a qualsiasi azione, anche delittuosa, pur di vedere sopraffatto l’avversario, l’azione si svolge sempre in un atteggiamento di fondamentale moderazione: lo scopo ultimo di Caṇakya non è l’eliminazione di Rākṣasa, bensì la possibilità di costringere il proprio avversario, di cui comunque riconosce le capacità e la scaltrezza politica, a divenire amico di Candragupta, che potrebbe così acquisire un valido e capace collaboratore [20].
Secondo una tradizione riferita da Plutarco [21], Candragupta in gioventù aveva visto Alessandro, e soleva ripetere che questi era stato a un passo dal conquistare tutta l’India, perché la popolazione locale, odiando i Nanda, sarebbe stata volentieri dalla sua parte. La scarsa simpatia degli Indiani per il sovrano pare fosse dovuta, oltre al carattere brutale del suo dominio, anche al fatto che i Nanda erano di bassa estrazione sociale: il primo sovrano della dinastia, Mahāpadma, che aveva usurpato il trono Magadha, secondo la tradizione era figlio di una madre di casta śūdra [22]. Tuttavia anche i Maurya (a quanto apprendiamo sia dal Mudrārākṣasa sia dalle fonti occidentali [23]) dovevano essere di estrazione sociale non elevata: l’adesione e il successivo sostegno dato al buddhismo possono essere stati motivati anche dalla necessità di trovare appoggio contro un’eventuale ostilità di parte brahmanica.
Nel suo intento di riunificare l’India, Candragupta perseguì anche il disegno di strappare ai Macedoni quei lembi di territorio al di là dell’Indo che Dario I e Alessandro si erano annessi: approfittando della confusione e delle lotte interne che indebolivano i regni dei diadochi, Candragupta venne alle armi con le truppe greche e sconfisse i generali Eudemo (che nel frattempo aveva rovesciato Taxile) e Pitone, lasciando ai greci solamente l’estremo lembo del Punjab settentrionale, dove regnava Sofite.
Attorno al 305 Seleuco Nicatore rivendicò la proprietà dei territori indiani che erano stati ripresi da Candragupta e oltrepassò l’Indo con un esercito [24]. Non ritenendosi in grado di affrontare un’avventura militare col re indiano, pensò che toccasse alla diplomazia risolvere la questione: strinse con Candragupta un trattato di alleanza col quale riceveva, in cambio della definitiva rinuncia ai territori perduti, 500 elefanti di guerra e stringeva un patto matrimoniale, che si inaugurava con la celebrazione delle nozze tra la figlia di Seleuco e un figlio di Candragupta [25]. Inoltre si rafforzarono i legami tra le due corti regali, con lo scambio di numerosi doni [26] e con l’invio di alcuni greci (tra cui Megastene) alla corte dei Maurya, perché studiassero la cultura e il modo di vivere degli Indiani.
Verso il 250, dopo una serie di eventi abbastanza confusi, la Partia e la Battria si proclamarono regni indipendenti. L’iniziativa della ribellione contro il sovrano seleucide Antioco II fu di un certo Diodoto (Teodoto secondo Giustino, ma la forma Diodoto è assicurata da Strabone e Trogo), che guidò la rivolta della Battriana. Nel frattempo un parto, Arsace, un uomo di incerta origine descritto come un predone, ma valoroso e capace, approfittando delle voci che davano Antioco sconfitto in un lontano paese occidentale, si era proclamato signore dell’Ircania. Nel momento in cui Seleuco II Callinico, il nuovo sovrano succeduto ad Antioco II, intervenne per riprendere possesso del paese, Arsace aveva stretto alleanza con Diodoto II, figlio di Diodoto, che nel frattempo era morto, e aveva sconfitto e costretto a ritirarsi Seleuco: secondo alcune fonti addirittura Seleuco sarebbe stato preso prigioniero, ma l’unica cosa certa è che fu costretto a sottoscrivere una pace che riconosceva la sovranità di Arsace sulla regione. Da quell’anno i Parti celebrarono con grande solennità il giorno della ritrovata indipendenza [27]. Gli avvenimenti comunque sono confusi: Strabone (XI 9, 2 s.) ne dà una versione diversa, la stessa cronologia è incerta, e secondo alcuni studiosi moderni Giustino avrebbe confuso due serie di avvenimenti tra loro distinte : secondo Narain [28] si deve porre attorno al 248-7 la rivolta della Partia («the Parthian era started in 248-247 B.C.») e attorno al 238 (ma forse qualche anno dopo) il tentativo di Seleuco II di restaurare il suo dominio sulla Partia. L’unica cosa che ci interessa in questa sede è lo stabilirsi di un regno greco-battriano per opera di Diodoto I e poi del suo successore Diodoto II, che per primo assunse il titolo regale. La monetazione indica chiaramente l’importanza e la leadership greca su questa regione. Attorno al 230 (secondo Polibio, o qualche anno più tardi, secondo Strabone) Diodoto II viene rovesciato da Eutidemo I, che consolidò il suo regno, aggiungendo probabilmente nuove province e nuovi territori a quelli già posseduti dal suo predecessore. I tentativi di riscossa da parte dei Seleucidi non sono però ancora terminati: nel 208 a.C., Antioco III, dopo una lunga serie di campagne militari che gli avevano consentito di ridurre all’obbiedenza i territori occidentali del suo regno, continuamente scossi da fremiti di rivolta e di emancipazione, compie un estremo tentativo di riconquista del regno battriano, sconfiggendo Eutidemo presso il fiume Ario (oggi Hari Rud) e costringendolo a ritirarsi nella città fortificata di Bactra. Dopo un assedio protrattosi per tre anni, i due contendenti, ormai stremati, decidono di venire a patti: Antioco conclude una pace onorevole per entrambi i contendenti, s’impegna a riconoscere Eutidemo, stringe un’alleanza con lui, e dà in matrimonio a sua figlia il figlio di Eutidemo, Demetrio.
3. Aśoka.
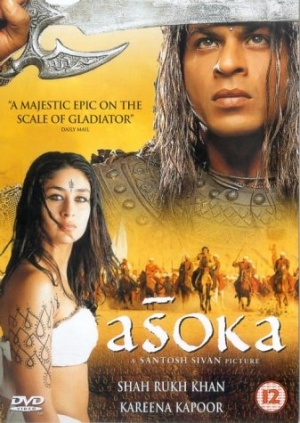 Nel periodo che corrisponde a questi avvenimenti
l’impero Maurya raggiunge il suo
apice con Aśoka (304-232)
[29]. Questi è noto
soprattutto per la sua pietà religiosa e per l’impegno che profuse nel
diffondere il buddhismo, ma fu anche uomo d’azione di grandi capacità
politiche e militari. La prima fase del suo regno, precedente la
conversione al buddhismo, è contrassegnata da
un atteggiamento aggressivo e brutale sia in politica interna
sia in politica estera. Aśoka giunse al trono nel 272 (ma
l’incoronazione vera e propria avvenne nel 268), favorito da una
congiura di palazzo, quando, al peggiorare delle condizioni di salute
del padre Bindusāra, alcuni ministri ostili al legittimo erede al trono
Suṣīma si rivolsero al principe (che era al momento lontano, impegnato
a domare la sollevazione della città greco-battriana di Takṣaśila) e lo
convinsero a rientrare nella capitale per assumere il potere. Aśoka si
lasciò convincere all’impresa, che condusse in maniera spietata,
uccidendo Suṣīma e tutti i fratellastri. Aśoka continuò la politica
espansionistica dei Maurya, giungendo fino a dominare quasi tutto il
subcontinente indiano (con l’esclusione dell’estrema parte meridionale
dell’India), gran parte del Bengala, alcune zone della Persia
orientale. Convertitosi poi al buddhismo, profuse innumerevoli energie
alla diffusione della dottrina buddhista non solo nell’India, ma anche
in paesi lontani, mandando anche monaci buddhisti nelle terre
occidentali col compito di predicarvi il dharma. La conversione
al buddhismo sarebbe stata, secondo la tradizione, conseguenza diretta
delle violenze compiute dal sovrano nel primo periodo di regno. In modo
particolare avrebbe influito sul suo animo
l’esito sanguinoso di un conflitto interno, a cui Aśoka era
stato costretto, otto anni dopo la sua incoronazione, per aver ragione
di uno dei suoi fratellastri che si era rifugiato a Kaliṅga. Poiché le popolazioni locali si erano
rifiutate di consegnargli il principe, Aśoka decise di intraprendere
una guerra e, dopo alcuni insuccessi iniziali, dovette scendere in
campo con tutto il suo esercito, provocando un eccidio di dimensioni
tragiche. Il giorno dopo la fine della guerra Aśoka, camminando tra le
migliaia di cadaveri disseminati nel campo
di battaglia, sentì il peso della sua colpa e maturò la
decisione di convertirsi al buddhismo.
Nel periodo che corrisponde a questi avvenimenti
l’impero Maurya raggiunge il suo
apice con Aśoka (304-232)
[29]. Questi è noto
soprattutto per la sua pietà religiosa e per l’impegno che profuse nel
diffondere il buddhismo, ma fu anche uomo d’azione di grandi capacità
politiche e militari. La prima fase del suo regno, precedente la
conversione al buddhismo, è contrassegnata da
un atteggiamento aggressivo e brutale sia in politica interna
sia in politica estera. Aśoka giunse al trono nel 272 (ma
l’incoronazione vera e propria avvenne nel 268), favorito da una
congiura di palazzo, quando, al peggiorare delle condizioni di salute
del padre Bindusāra, alcuni ministri ostili al legittimo erede al trono
Suṣīma si rivolsero al principe (che era al momento lontano, impegnato
a domare la sollevazione della città greco-battriana di Takṣaśila) e lo
convinsero a rientrare nella capitale per assumere il potere. Aśoka si
lasciò convincere all’impresa, che condusse in maniera spietata,
uccidendo Suṣīma e tutti i fratellastri. Aśoka continuò la politica
espansionistica dei Maurya, giungendo fino a dominare quasi tutto il
subcontinente indiano (con l’esclusione dell’estrema parte meridionale
dell’India), gran parte del Bengala, alcune zone della Persia
orientale. Convertitosi poi al buddhismo, profuse innumerevoli energie
alla diffusione della dottrina buddhista non solo nell’India, ma anche
in paesi lontani, mandando anche monaci buddhisti nelle terre
occidentali col compito di predicarvi il dharma. La conversione
al buddhismo sarebbe stata, secondo la tradizione, conseguenza diretta
delle violenze compiute dal sovrano nel primo periodo di regno. In modo
particolare avrebbe influito sul suo animo
l’esito sanguinoso di un conflitto interno, a cui Aśoka era
stato costretto, otto anni dopo la sua incoronazione, per aver ragione
di uno dei suoi fratellastri che si era rifugiato a Kaliṅga. Poiché le popolazioni locali si erano
rifiutate di consegnargli il principe, Aśoka decise di intraprendere
una guerra e, dopo alcuni insuccessi iniziali, dovette scendere in
campo con tutto il suo esercito, provocando un eccidio di dimensioni
tragiche. Il giorno dopo la fine della guerra Aśoka, camminando tra le
migliaia di cadaveri disseminati nel campo
di battaglia, sentì il peso della sua colpa e maturò la
decisione di convertirsi al buddhismo.
Nella storia del buddhismo indiano Aśoka è un personaggio di grandissimo rilievo, attorno al quale sono sorte anche leggende edificanti. La più nota, tramandata in quella che è la fonte essenziale per seguire le vicende di Aśoka, l’Aśokāvadāna [30], è il cosiddetto racconto del “dono di polvere”. La nascita di Aśoka, secondo questo racconto, sarebbe stata profetizzata dallo stesso Buddha, quando un bambino, di nome Jaya, un giorno al suo passaggio, per dimostrare il suo affetto, gli gettò nella ciotola del cibo la polvere con cui stava giocando, accompagnando la sua offerta con una formula di benedizione e di augurio. Comprendendo la generosità e la spontaneità del gesto del bambino, il Buddha riconobbe il grande destino che avrebbe avuto in sorte il bimbo in una delle sue reincarnazioni future e così profetizzò: «Cento anni dopo la mia morte ci sarà un imperatore di nome Aśoka in Paṭaliputra [31]: egli governerà uno dei quattro continenti e adornerà Jambudvipa [32] con le mie reliquie costruendo 84.000 santuari per il benessere del popolo, e li renderà onorati da dèi ed uomini. La sua fama si estenderà ovunque. Il suo dono meritorio è stato proprio questo: Jaya ha gettato un manciata di polvere nella ciotola del Buddha» [33].
Per quanto Aśoka non avesse mai inteso rendere il buddhismo religione ufficiale del suo regno, molte leggi da lui promulgate seguono i principi buddhisti, soprattutto nell’affermare il rispetto degli anziani, il dovere dell’obbedienza ai genitori, il divieto della caccia e l’uso di una dieta priva di carni. Di questa legislazione che ha permesso un’ampia pratica della pietà nel suo regno il sovrano rende conto in una serie di epigrafi di diversa estensione (alcune particolarmente lunghe, altre molto sintetiche) che vengono collocate in varie regioni dell’India. In alcuni di questi editti si ricorda molto dettagliatamente il fatto che la pratica della pietà si è diffusa anche tra le molte popolaioni stanziate entro i confini dell’India. In un editto in particolare però si nota con rammarico il fatto che la pratica della religione, buddhista o brahmanica, ha scarsamente coinvolto i Greci:
Non c’è paese, ad eccezione dei Greci, dove non esistono queste classi, i brāhmaṇa e gli asceti. E non c’è paese in cui non esistano o si sia cessato di avere onore e adesione a una comunità religiosa (Ed. 13, 9).
Tuttavia lo stesso re fa sapere altrove di avere contribuito a diffondere la dottrina buddhista anche nei paesi governati dai Greci. Si legge infatti in un altro editto che il re ha inviato in tutto il regno funzionari della legge religiosa, col compito di verificare eventuali abusi, e tra le popolazioni coinvolte in questa politica sono esplicitamente menzionati i Greci (5, 9). In un altro editto Aśoka menziona la sua politica sanitaria, che è consistita nel fornire assistenza medica, sia per gli uomini sia per gli animali, in tutte le parti del suo impero e anche tra i vicini, tra i quali viene ricordato il territorio di «Antioco, re dei Greci, e coloro che abitano nelle vicinanze di questo re Antioco» (2, 1). In un altro editto ancora Aśoka mette in rilievo il fatto che la conoscenza della dottrina buddhista si è estesa a grandissima distanza dal suo regno, fino «a seimila yojana dal suo regno, là dove c’è il re dei Greci di nome Antioco, e ancora più in là di Antioco, dove ci sono i re di nome Tolomeo, Antigono, Magas [Magante di Cirene], e Alessandro» (13, 16).
Non solo risultano da vari documenti le
iniziative di Aśoka volte alla diffusione del buddhismo in Occidente,
ma si deve considerare certo che il buddhismo suscitò una discreta
simpatia tra i Greci: sappiamo che nei monasteri buddhisti non mancava
la presenza di greci, e in uno dei documenti che narrano le vicende di
Aśoka si afferma 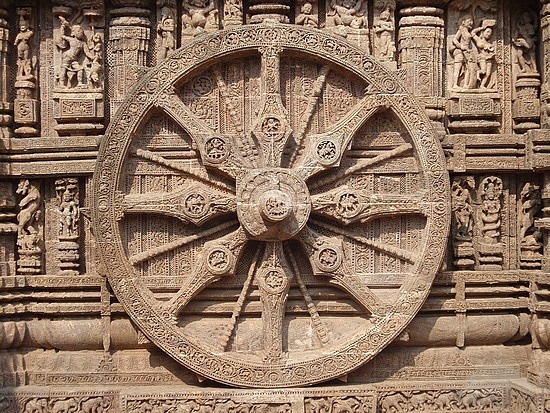 che venne inviato nei paesi occidentali col compito di
predicare la fede un greco che aveva assunto il nome di Dhammarakkhita
[34]. Che
nel mondo greco-ellenistico la conoscenza del buddhismo si sia
mantenuta anche nei secoli successivi è provato in maniera certa sia
dal rinvenimento in Egitto di una pietra risalente all’epoca dei
Tolomei in cui è inciso il
dhammacakka
[35]
sia dagli accenni al
buddhismo che si trovano in autori
dell’età
imperiale, cristiani e pagani, tanto che si è ammessa la
presenza di una comunità di buddhisti ad Alessandria d’Egitto attorno
al II sec. d.C. Clemente Alessandrino, citando gli influssi delle
antiche filosofie straniere sul pensiero dei Greci, nomina infatti
esplicitamente il buddhismo:
che venne inviato nei paesi occidentali col compito di
predicare la fede un greco che aveva assunto il nome di Dhammarakkhita
[34]. Che
nel mondo greco-ellenistico la conoscenza del buddhismo si sia
mantenuta anche nei secoli successivi è provato in maniera certa sia
dal rinvenimento in Egitto di una pietra risalente all’epoca dei
Tolomei in cui è inciso il
dhammacakka
[35]
sia dagli accenni al
buddhismo che si trovano in autori
dell’età
imperiale, cristiani e pagani, tanto che si è ammessa la
presenza di una comunità di buddhisti ad Alessandria d’Egitto attorno
al II sec. d.C. Clemente Alessandrino, citando gli influssi delle
antiche filosofie straniere sul pensiero dei Greci, nomina infatti
esplicitamente il buddhismo:
(precedettero i Greci...) i gimnosofisti degli Indiani e altri filosofi barbari. Duplice è la loro stirpe, gli uni sono i Sarmani [śramaṇa-, i monaci buddhisti [36]], gli altri Brahmani. E quelli dei Sarmani che sono chiamati ‘abitatori della selva’ né abitano in città né hanno case, ma si vestono di cortecce di alberi e si cibano di germogli e bevono l’acqua con le mani, non praticano né matrimonio né generazione di figli, come quelli che ora si chiamano Temperanti. Ci sono poi alcuni Indiani che ubbidiscono ai precetti di Butta, che onorano come dio per la grandezza sua eccellenza [37].
Molti particolari in più, in un contesto più o meno simile, ma senza riferimento al nome del Buddha [38], si ritrovano in Strabone (XV 1, 59 ss.). Entrambi gli autori evidentemente hanno attinto alla stessa fonte, Megastene [39], esplicitamente nominato da Strabone. La disponibilità dei Greci ad accogliere gli insegnamenti del buddhismo non deve sorprendere, se si ricorda che le filosofie del periodo ellenistico hanno molti tratti in comune col buddhismo, a partire dalla prevalenza dell’etica sulla metafisica (che il buddhismo non solamente ignora, ma mette esplicitamente da parte, in quanto il dibattito sull’immortalità dell’anima o problemi analoghi può generare attaccamento, e l’attaccamento distrae l’uomo dalla strada della salvezza), e comune è lo stesso fine a cui la dottrina è indirizzata: l’ottenimento della felicità. Del resto, al di là del comune sentire che poteva esistere tra buddhismo e alcune scuole filosofiche ellenistiche su determinati problemi etici, il fascino culturale di quelle terre lontane era percepito da secoli.
Di grande rilevanza in questo contesto pare dunque l’esistenza di un editto di Aśoka redatto in greco e rinvenuto nel 1963 a Shar-i-kuna, nei pressi di Kandahar (nell’odierno Afghanistan), l’antica Alexandria Arachosia. L’iscrizione è bilingue, e accanto al testo greco abbiamo una versione aramaica dello stesso testo. L’aramaico era la lingua ufficiale dell’impero achemenide, e in aramaico sono redatte due altre iscrizioni di Aśoka (purtroppo molto frammentarie), venute alla luce nel 1969 in un’altra zona dell’Afghanistan (la provincia di Laghman, l’antica Lampaka). L’iscrizione greco-aramaica, già conservata nel Museo di Kabul, è oggi dispersa. Accanto a questa iscrizione (vedi Appendice) sono state scoperte, in epoca più recente, due altre iscrizioni frammentarie, che sono in realtà traduzioni greche parziali di editti già noti in India (e indicati col n. 12 e 13 nelle edizioni correnti).
Nell’iscrizione greco-aramaica Aśoka enumera, sul modello di altre iscrizioni lasciate in India, i benefici arrecati dai suoi dieci anni di regno e i miglioramenti prodottisi tra i sudditi nel rispetto delle regole della pietà. Non è certo che questa iscrizione fosse collocata in un’area che effettivamente ricadeva sotto la giurisdizione di Aśoka, in quanto è difficile determinare in modo esatto il confine occidentale del suo regno: dal testo dell’editto non si desume in modo diretto che Aśoka governasse queste terre, e poiché anche in altre epigrafi Aśoka si vanta di avere promosso la diffusione del buddhismo (anche con operazioni umanitarie) al di fuori del suo regno, non è inverisimile la collocazione di un’epigrafe in un regno vicino, soprattutto se i rapporti col re confinante erano buoni, con lo scopo di fare conoscere il miglioramento del tenore di vita della popolazione ottenuto grazie a un indirizzo politico improntato alla dottrina buddhista (un messaggio a scopo promozionale, diremmo oggi): è possibile insomma che l’area fosse governata in quel periodo da Diodoto I [40]. Escludendo l’ipotesi estremista che Aśoka e Diodoto fossero la stessa persona [41], resta il fatto piuttosto inusuale di un’iscrizione in lingua greca indirizzata a una terra sulla quale Aśoka non aveva un effettivo potere. Evidentemente questo dimostra da una parte un singolare interesse per le popolazioni di lingua greca e per la diffusione dei precetti buddhisti nel mondo ellenistico, dall’altra la probabile presenza di consistenti comunità di greci convertiti al buddhismo in una zona confinante, ma indipendente dal suo impero.
4. Tra Aśoka e Menandro.
Con la morte di Aśoka (232) inizia la decadenza dell’impero Maurya. L’estendersi della devozione non aveva fatto diminuire le possibilità di congiure e di complotti di palazzo. L’erede designato di Aśoka, il figlio Kunāla, fu reso cieco, e quindi impossibilitato a governare, da una delle vedove di Aśoka, la regina Padmapatī. Ad Aśoka succedette un altro figlio, Daśaratha. Per qualche decennio salgono sul trono figure meno rilevanti di sovrani, e anche l’estensione dell’impero Maurya subisce considerevoli riduzioni. È in questo contesto di progressiva decadenza che s’inserisce il nuovo tentativo del sovrano seleucide Antioco III (223-187) di ripresentarsi con un esercito ai confini dell’India. Reduce dal sostanziale insuccesso contro Eutidemo, Antioco decide di imitare le imprese del suo grande predecessore Alessandro e di rifarne il cammino. A giudicare dal racconto di Polibio, non si trattò tanto di una campagna militare, quanto di una manifestazione di interesse (amichevole o no), nei confronti dell’India, considerando che la situazione di debolezza dell’impero Maurya consentiva una vantaggiosa ridefinizione del vecchio trattato di alleanza risalente ai tempi di Candragupta. Secondo il racconto di Polibio infatti Antioco III lasciò l’India con un notevole carico di ricchezze e di equipaggiamenti militari (gli elefanti):
Oltrepassato il Caucaso e disceso in India, (Antioco) rinnovò l’amicizia con Sofagaseno re degli Indiani, e presi un certo numero di elefanti, così da fare ammontare il numero complessivo a centocinquanta, e ancora avendo provveduto di nuovo sul posto all’approvigionamento delle truppe, ritornò con l’esercito e lasciò Androstene di Cizico col compito di scortare i tesori che gli erano stati accordati dal re. Dopo essere passato attraverso l’Aracosia e avere guadato il fiume Erimanto, giunse attraverso la Draghena fino alla Carmania, dove, approssimandosi ormai l’inverno, pose i quartieri invernali [42].
Più che un re, il Sofagaseno di cui parla Polibio (Subhāgasena o Subhāgsena nelle fonti indiane) è presumibilmente un principe locale a servizio dei Maurya. Secondo altri potrebbe essere identificato con Vīrasena, uno dei figli di Aśoka.
Il 185 vede la fine dell’impero Maurya e la scomparsa dell’ultimo sovrano della dinastia, Bṛhadratha, deposto e ucciso nel corso di una rivolta scoppiata durante un’ispezione del sovrano alle truppe reali, rivolta capeggiata da Puṣyamitra ŚuŅga, un brahmano a servizio dei Maurya come generale dell’esercito (senapati). Il nuovo governo è presentato dalle fonti indiane come profondamente ostile al buddhismo, e parla di persecuzioni violente che si concretizzano in distruzioni di monasteri buddhisti con relativa uccisione di monaci, abbattimento di santuari e razzie di reliquie [43]. Per quanto le fonti, d’intonazione buddhista e quindi presumibilmente di parte, possano avere esagerato nella descrizione dei fatti, è innegabile che il rovesciamento dell’impero Maurya corrisponde comunque a una rinnovato slancio degli ambienti brahmanici, sempre più insofferenti della crescente penetrazione del credo buddhista nelle masse. Che comunque questa fosse la linea a cui voleva inspirarsi l’azione del nuovo sovrano si deduce con certezza anche dai segnali da lui largamente disseminati di ritomo alle pratiche brahmaniche, ad esempio con la celebrazione dell’aśvamedha, il sacrificio del cavallo, destinato all’ottenimento della fertilità e della gloria reale [44]. Si trattava di una cerimonia di ascendenza antichissima, che poteva essere celebrata solamente da una figura regale (rājā) e che, per la sua magnificenza e dispendiosità, aveva anche un enorme valore d’immagine, indubbiamente superiore allo stesso valore cultuale e salvifico, dal momento che l’apparato e lo sfarzo del rito manifestava ai sudditi la larghezza di mezzi di cui disponeva il sovrano che ne ordinava la celebrazione. Proprio per i suoi costi e la sua durata, questo rito veniva compiuto una sola volta nel corso della vita di un sovrano. Anche in politica estera la nuova dinastia sembra volere segnare un deciso cambiamento di indirizzo rispetto al passato: fin dai primi anni di regno Puṣyamitra rivolge le proprie attenzioni contro vari territori che in un modo o nell’altro erano venuti meno alla sua autorità: tra questi vi è anche il regno greco-battriano, il cui re Demetrio II, che era successo al padre Eutidemo attorno al 200, era alleato di Bṛhadratha: questa mossa però finì per risultare tutt’altro che felice.
5. Il regno Indo-greco fino a Menandro.
 La molla che spinse Demetrio II ad
affrontare
manu militari l’India fu data probabilmente non solo dall’alleanza
che lo legava a Bṛhadratha, ma anche dal desiderio di difendere da
eventuali vessazioni del sovrano Śuṅga le minoranze greche presenti
nell’India nord-occidentale (posto che il buddhismo aveva avuto una
profonda penetrazione fra queste popolazioni, esse potevano trovarsi in
un clima quanto meno di instabilità, di fronte all’irrigidirsi della
politica filo-brahmanica della nuova dinastia). Inoltre era
l’anche
l’occasione per annettere di nuovo i territori dell’impero di
Alessandro ceduti all’India fin dai tempi di Candragupta.
La molla che spinse Demetrio II ad
affrontare
manu militari l’India fu data probabilmente non solo dall’alleanza
che lo legava a Bṛhadratha, ma anche dal desiderio di difendere da
eventuali vessazioni del sovrano Śuṅga le minoranze greche presenti
nell’India nord-occidentale (posto che il buddhismo aveva avuto una
profonda penetrazione fra queste popolazioni, esse potevano trovarsi in
un clima quanto meno di instabilità, di fronte all’irrigidirsi della
politica filo-brahmanica della nuova dinastia). Inoltre era
l’anche
l’occasione per annettere di nuovo i territori dell’impero di
Alessandro ceduti all’India fin dai tempi di Candragupta.
Due potenti eserciti invasero l’India, l’uno da Nord guidato da Apollodoto, forse parente di Demetrio, l’altro da Ovest guidato da Menandro, uno dei generali di Demetrio. Non è agevole seguire l’esatto svolgersi degli avvenimenti, perché le fonti di parte greco-romana [45] sono confuse e contraddittorie, e quelle di parte indiana pressoché inesistenti: se si escludono allusioni isolate in opere letterarie, l’unico testo di un certo valore è lo Yuga-Purāṇa (“Storia delle età”), che, risalendo attorno al 250 d.C. [46], è comunque lontano centinaia di anni dagli avvenimenti, che peraltro non vengono riferiti come una narrazione storica, bensì prospettati in forma di profezia [47]. Nonostante il carattere frammentario delle narrazioni, alcuni punti possono essere fissati con certezza.
a. L’avanzata greca ebbe all’inizio pieno successo e si spinse fino a PaĘaliputra, la capitale del regno dei Śuṅga. Demetrio fa anche fondare una nuova città a cui viene dato il nome di Demetriade. Strabone (XV 1, 27) narra genericamente di Greci che, dopo Alessandro, si spinsero fino al Gange e a Palimbroto (il nome dato dalle fonti greche a Paṭaliputra) [48]. Anche le fonti indiane parlano di un’avanzata che tocca la città di Sāketa, di Mathurā (nell’odierno Uttar Pradesh) e infine di Paṭaliputra [49].
b. L’invasione si traduce in una vera e propria occupazione del Madhyadeśa, la regione centrale dell’India. Questa occupazione provoca un completo stravolgimento delle tradizioni e dei costumi indiani, con un sostanziale abbattimento delle distinzioni castali. Secondo la narrazione dello Yuga Purāṇa, «Alla fine dell’epoca (yuga) ci saranno non-ari che osserveranno le pratiche religiose degli ari. I brāhmaṇa, gli kṣatriya, i vaiśya saranno uomini di basso valore come i śūdra. Certamente essi vestiranno tutti allo stesso modo e si comporteranno tutti allo stesso modo. Alla fine dell’epoca gli uomini (che praticano l’ortodossia) saranno mischiati con sette eretiche. Romperanno poi l’amicizia per cause di donne. Non vi è dubbio su questo. (...) I śūdra diranno bho, e i brahmani proferiranno ārya, e gli anziani, i più timorosi della morale, sfrutteranno senza paura la gente» [50].
c. In grazia di questi avvenimenti, Demetrio ottiene il titolo di “invincibile” (ἀνίκητος) e fa coniare monete in cui appare con una proboscide di elefante, simbolo del suo dominio sull’India: alcune monete sono bilingui, con scritte in greco e in pracrito. In sostanza con Demetrio II comincia a prendere corpo l’esistenza di un regno indo-greco che non si estende solamente sulle estreme propaggini dell’India nord-occidentale, ma penetra in profondità nell’India centro-settentrionale fino all’Himalaya. Nei territori controllati dai re indo-greci si insediano corpose comunità greche, che divengono in alcuni casi vere e proprie colonie, con un governo stabile e leggi autonome, e in sostanza con una costituzione che si ispira a quella delle poleis greche.
d. Dopo otto anni di permanenza in India [51], nel 162 una serie di avvenimenti obbliga i Greci ad abbandonare PaĘaliputra. In particolare, Demetrio è costretto a ripiegare e ad abbandonare almeno parte del terreno conquistato [52], in quanto nella madre patria è scoppiata una sollevazione guidata da Eucratide, un generale ribelle, imparentato forse col sovrano seleucide Antioco IV. Messo sotto assedio da Demetrio e indebolito dalla necessità di coprire il fianco sinistro dalle possibili sollevazioni di tribù confinanti e ribelli, Eucratide alla fine riesce comunque ad avere ragione di Demetrio, assume il potere e lo sostituisce anche come re dell’India [53]. L’effettiva ascesa di Eucratide al potere in India è confermata dalla presenza di una monetazione in cui il nome di Eucratide è accompagnato dall’epiteto βασιλευσ μεγασ. Per contro, le armate di Menandro, che operano in un’altra zona dell’India (presumibilmente nell’area del Punjab), restano sulle loro posizioni [54].
6. Menandro
 Al termine di questa travagliata serie di
vicende, non sempre facilmente decifrabili, emerge la figura di
Menandro, il più importante tra i re del regno indo-greco.
Al termine di questa travagliata serie di
vicende, non sempre facilmente decifrabili, emerge la figura di
Menandro, il più importante tra i re del regno indo-greco.
Dopo alcuni anni di avanzate vittoriose, le imprese di Eucratide vengono bruscamente interrotte dalla sua morte: Eucratide viene ucciso dal figlio, che aveva associato al regno [55]. Suoi successori sul regno di Battriana furono il figlio Eucratide II e poi Eliocle, forse ultimo sovrano greco della regione.
All’avanzata di Eucratide si oppose Menandro, che aveva comandato le armate di Demetrio al momento dell’invasione dell’India. Procedendo verso Occidente Menandro costrinse Eucratide a ripiegare e conquistò e consolidò un vasto regno, che comprendeva le parti orientali (indiane) di quello che era stato il regno di Demetrio, configurandosi così per la prima volta come un vero e proprio regno indo-greco. Il suo dominio si stendeva su un ampio territorio dell’India nord-occidentale e aveva probabilmente come capitale Sagala [56].
Il regno indo-greco di Menandro non è più l’appendice orientale di un regno ellenistico, ma è una realtà completamente nuova. Il sincretismo tra cultura greca e cultura indiana giunge a livelli inattesi, come si riconosce già dal convivere dell’immagine di Atena Alc idemo (‘protettrice del popolo’), raffigurata sulle monete di Menandro (con scritte bilingui greco-pracrite), e della dottrina buddhista, alla quale Menandro si sarebbe convertito. Va premesso innanzitutto che non abbiamo prove concrete di questa conversione di Menandro [57]: è probabile che il sovrano greco abbia guardato con tolleranza o addirittura con simpatia il buddhismo, ma soprattutto è probabile che si fosse contrapposto alla politica filobrahmanica e antibuddhista dell’impero ŚuŅga, così da permettere il diffondersi di voci e di tradizioni che parlano apertamente di una sua conversione al buddhismo.
Nella tradizione buddhista Menandro è nominato più volte e sempre con molto rispetto. Alla vicenda della sua conversione è dedicata una delle più interessanti ed estese opere della letteratura buddhista in pāli, il Milindapañha (“Le domande di Menandro”) [58], la cui redazione non deve essere di molto posteriore alla morte di Menandro. Raffigurazioni di Menandro sembra che ricorrano in santuari contenenti reliquie buddhiste (stūpa), e il suo nome si legge in un’iscrizione dedicatoria scoperta in una teca di reliquie buddhiste nel Bajaur (Pakistan), ove si accenna a un avvenimento svoltosi in un determinato anno del regno mahārājasa minadrasa ‘del gran re Minadras (Menandro)’.
Dopo la sua morte, avvenuta, a quanto sembra dalle fonti greche, durante una campagna militare, diversi capi si disputarono le sue ceneri, che alla fine furono suddivise e portate in varie località, dove furono conservate in reliquiari (stūpa) e divennero oggetto di devozione: questo episodio, narrato di passaggio anche da Plutarco [59], ricorda l’analoga spartizione delle ceneri del Buddha, con conseguente fondazione di stūpa in diverse città dell’India. È curioso comunque che Plutarco parli di questo sovrano come “di un tal Menandro” (Μενάνδρου δέ τινος) e gli attribuisca il governo della Battriana, quando in realtà il suo regno era più ad oriente di questa regione: evidentemente in occidente non giungeva che una pallida eco degli avvenimenti e dei personaggi di quei paesi lontani. Secondo il Milindapañha Menandro sarebbe divenuto un arhat, cioè un discepolo che ha raggiunto la completa perfezione e meritato il nirvāṇa. Quel che è certo è che, come affermato anche da altre fonti buddhiste oltre che dallo stesso Milindapañha, durante il regno di Menandro si assiste a una notevole ripresa del proselitismo buddhista condotto anche da greci. Secondo una fonte singalese, durante il regno di Menandro il monaco Yona (Greco) [60] Mahadhammarakkhita sarebbe giunto da Alessandria del Caucaso insieme a trentamila monaci per la cerimonia di fondazione di un santuario buddhista [61]. Per quanto la cifra possa apparire esagerata o convenzionale, tutte queste allusioni dànno una chiara immagine da una parte del diffondersi della dottrina buddhista tra le minoranze greche dell’India, dall’altra del mescolarsi sempre più profondo delle due tradizioni culturali.
Il Milindapañha, che è considerato da alcune scuole buddhiste come una delle opere più autorevoli e importanti, secondo per valore solamente ai piĘaka [62], sembra uno dei prodotti più caratteristici di questa interazione tra le due culture. Si tratta di un dialogo tra il re Menandro e un dotto e venerabile monaco buddhista, Nāgasena, reincarnazione di un altro pio e famoso monaco, Mahāsena, che, ormai giunto al termine del suo cammino di purificazione, già si trovava nel cielo dei deva e riceve dal capo dei deva Sakka l’ordine esplicito di ritornare sulla terra, perché lui soltanto avrebbe potuto essere adatto a un compito così impegnativo, adeguato maestro di uno scolaro tanto illustre e tanto desideroso di apprendere: Menandro desidera conoscere in modo più approfondito la dottrina buddhista, e il monaco risponde in modo circostanziato alle sue domande. Il re appare instancabile e desideroso continuamente di approfondire, e ogni nuova domanda è l’occasione per chiarire e precisare il contenuto della precedente risposta. Il contenuto dell’opera è completamente pervaso dallo spirito dell’India, ma la forma dialogica ha indotto qualche studioso a richiamare Platone [63].
Nella sua redazione attuale il Milindapañha consta di sette libri, ma vari indizi inducono a credere che solamente i primi tre [64] siano da considerare antichi: i libri 4-7 sembrano un’aggiunta posteriore. Infatti, oltre al fatto che i libri 4-7 appaiono da una punto di vista stilistico più scadenti, è stato notato anche che, mentre i primi libri dibattono questioni di primaria importanza per chi vuole avvicinarsi alla dottrina, buddhista, gli ultimi libri hanno un contenuto apologetico. È significativo che le due antiche versioni in cinese (peraltro di diversa estensione e con alcune differenze rispetto all’originale indiano) conoscano solamente i primi tre libri. Circa la data di composizione, un sicuro termine ante quem è il IV sec. d.C., quando il Milindapañha è citato in autorevoli testi e commenti buddhisti. Ma è probabile che l’opera sia stata redatta in un’epoca non molto posteriore alla morte di Menandro.
L’ipotesi di un influsso dei dialoghi platonici sull’opera fu avanzata già da studiosi del XIX secolo e poi sostanzialmente abbandonata. Ma il fatto che sia stata riproposta, a distanza di anni, l’ipotesi, ancora meno verosimile, che alla base del Milindapañha stia un’opera come la Lettera dello Pseudo-Aristea a Filocrate [65] mostra che è difficile, nella lettura del Milindapañha, liberarsi dalla sensazione che sullo sfondo dell’opera vi sia stato comunque un modello greco. Si è anche pensato che il Milindapañha rifletta una specie di verbale, redatto in greco, di un dialogo effettivamente avvenuto tra Menandro e un esponente buddhista [66], verbale successivamente rielaborato in forma letteraria nell’India meridionale [67] Tuttavia non solamente l’apparato dottrinale pienamente buddhista e gli aspetti correlati, ma anche il modo dell’esposizione e delle descrizioni hanno poco di greco e molto di indiano: il Milindapañha è un’opera nata in India che si colloca a pieno titolo nella tradizione letteraria indiana, e tra le fonti del testo vanno sicuramente annoverati i dialoghi delle Upaniṣad (con la differenza che in questi è spesso il re che esce a testa alta dal confronto col brahmano, mentre qui, pur risultando alla fine una prevalenza di Nāgasena, entrambi gli antagonisti riconoscono in modo cavalleresco il valore dell’avversario) e in generale i testi della letteratura buddhista (si vedano gli estratti che riportiamo nell’Appendice II [68]).
7. Decadenza del regno indo-greco.
Dopo la morte di Menandro, avvenuta attorno al 130, le vicende del regno indo-greco sono avvolte da una nebbia che non consente di discernere in modo netto personaggi e avvenimenti. Pressoché assenti le fonti di parte greca o greco-romana (del tutto indifferenti alle vicende di quest’area remota dove pure si svolge un episodio importante della cultura greco-ellenistica), inesistenti, come di consueto, le fonti storiche indiane, i dati principali ci vengono o da scarni accenni delle cronache cinesi [69] o da documenti di prima mano, ma sporadici e difficili da utilizzare, in assenza di narrazioni dirette degli avvenimenti, come le iscrizioni e le monete. Possiamo riassumere molto sinteticamente i dati di fatto sicuri nei seguenti punti:
a. Dopo Menandro inizia la decadenza del regno indo-greco, la cui estensione si riduce progressivamente, sotto la pressione di popolazioni esterne quali gli Sciti e gli Yue-zhi (provenienti dall’Asia centrale, da dove erano stati cacciati dagli Unni).
b. Attorno al 125 gli Sciti prima e gli Yue-zhi poi penetrarono in Battriana e uccisero il re Eliocle, ponendo virtualmente fine al regno greco-battriano, anche se, a quanto sembra, un ultimo brandello di territorio nella parte meridionale rimase ancora per qualche tempo sotto il dominio di un re Eucratide II, del quale si hanno alcune monete con la scritta σωτηρ. Per contro il regno indo-greco, sia pure con un’estensione più ridotta, frammentato tra più sovrani e con alterne vicende di perdite e riconquiste di territori (ad esempio, attorno al 70 a.C. con Apollodoto II la perdita dei territori occidentali del regno sarebbe stata compensata da una espansione in Oriente, con la conquista del Punjab orientale), resistette per più di un secolo, fin dopo l’inizio dell’era cristiana. Nel frattempo Sciti e Yue-zhi allargavano i loro domini verso Sud, fino a costituire due regni sulle coste occidentali dell’India, e da qui, nel corso di alcuni secoli, partono poi alla conquista dell’India settentrionale.
c. Conosciamo i nomi di diversi sovrani (una ventina), ma anche semplicemente sistemarli in ordine cronologico e indicare in quali territori esattamente si estendeva il loro dominio è opera controversa. Quanto viene affermato alla fine del Milindapañha (in un libro la cui autenticità è comunque sospetta) che Menandro alla fine della sua vita, seguendo una prassi diffusa tra gli Indiani, si sarebbe ritirato in una selva penitenziale per divenire un arhat, lasciando il regno al figlio, è assai poco probabile. L’ipotesi, comunemente accolta fino a poco tempo fa, che alla morte di Menandro il regno si sarebbe suddiviso tra la vedova Agatocleia (che avrebbe fatto da reggente per il figlio Stratone) e Zoilo I, è oggi messa in discussione, e la cronologia di Agatocleia viene spostava a un’epoca più avanzata. Dei re che governarono nel periodo successivo alcuni dovevano appartenere alla discendenza di Menandro, altri presumibilmente alla discendenza di Eutidemo.
d. Zoilo I potrebbe essere stato promotore di un’alleanza con gli Yue-zhi: lo proverebbe la presenza sulle sue monete di una clava di Eracle insieme con un arco ricurvo, simile a quelli usati nelle steppe dell’Asia centrale.
e. Le monete con raffigurazioni ispirate
alla cultura e alla religione greca presentano tipi diversi.  Seguendo
la classificazione di Narain [70] avremmo cinque tipi fondamentali:
Seguendo
la classificazione di Narain [70] avremmo cinque tipi fondamentali:
– Un tipo fondamentale di monete che presenta la raffigurazione di Zeus;
– Monete che presentano la raffigurazione di Pallade e Apollo; in particolare, le monete che rappresentano Atena Alkidemos sembrano collegate con sovrani appartenenti alla famiglia di Menandro.
– Monete che presentano il re su un cavallo rampante;
– Monete che presentano la raffigurazione di Eracle;
– Monete che presentano la raffigurazione di Artemide.
Vi sono anche monete che non rientrano nei tipi descritti: p.es. Diomede, che fu re della Paropomaside attorno al 95-90 a.C., predilige la raffigurazione dei Dioscuri.
Accanto alle tradizionali monete rotonde
di tipo greco, sono coniate anche monete quadrate. La maggior parte
delle monete presentano scritte bilingui (greco e pracrito). Nel
complesso, sembra che nel prosieguo del regno indo-greco si assista a
una progressiva “indianizzazione” delle monete [71].
Sulla base di questi elementi [72] gli studiosi hanno tentato di disegnare un quadro storico, che però è tutto da verificare e presenta lacune e incertezze.
f. La fine dell’avventura greco-ellenistica in India si può collocare attorno al 10 d.C., quando l’ultimo sovrano, Stratone II Sotere, che probabilmente governava insieme col nipote Stratone III Filopatore, fu deposto, e il suo regno conquistato da Rajuvula, il re degli Indo-Sciti.
g. Continuarono anche dopo Menandro interscambi frequenti e fruttuosi tra i sovrani del regno indo-greco e le altre regioni dell’India.
Con la fine del regno indo-greco non cessa né la presenza di minoranze greche in India né la circolazione di elementi di cultura greco-ellenistica in quella lontana regione. Le città popolate da Greci, che si amministravano con un ordinamento simile a quello delle poleis, preservarono almeno per qualche tempo la loro autonomia, e si continuò a parlare in greco almeno per un breve periodo [73]. Il Periplo del mar Rosso, un’opera di interesse geografico databile attorno al I sec. d.C., che
descrive luoghi che si trovano nella rotta dal mar Rosso al golfo Persico e all’Oceano indiano, afferma che ai suoi tempi ancora circolavano a Barigaza [74] dracme greche, ricordo della campagna indiana di Alessandro e poi dei re che dopo di lui avevano regnato in India, Apollodoto e Menandro [75]. Anche le monete dei regni indiani o indo-parti che si collocarono sui territori dello scomparso regno indo-greco continuarono ancora per qualche tempo ad avere sulle monete scritte in greco (non di rado con errori di grammatica) o almeno dei monogrammi greci [76].
Nel periodo successivo i rapporti tra India e mondo occidentale sicuramente si diradarono, ma non cessarono del tutto. Accenni, più o meno velati, a personaggi greci continuano a trovarsi nelle opere della letteratura indiana [77]. Continuarono, e in alcune epoche prosperarono, i commerci, prevalentemente via mare, e sappiamo che delegazioni e ambascerie di Indiani giunsero a Roma all’epoca di Augusto e poi di Antonino Pio. L’accenno all’«ordine di battaglia di Cesare» in un’opera buddhista [78] e i copiosi ritrovamenti di monete romane in India (insieme col prestito del termine dīnāra ‘moneta soprattutto d’oro’ da lat. dēnārius, importato in India attorno all’età di Augusto) mostrano che il filo che legava l’India al mondo classico divenne forse più tenue, ma non si spezzò del tutto.
A quest’epoca risalgono iscrizioni con dediche buddhiste scritte da Greci in India: ad es. un certo Teodoro, che ricopriva la carica di meridarca (cioè governatore di una provincia), scrive la seguente dedica su un vaso contenente reliquie del Buddha e rinvenuto in un santuario buddhista nella regione di Swāt [79]:
Dal meridarca Teodoro è stata stabilita questa reliquia del beato Śakyamuni per il benessere del popolo [80].
 La migliore testimonianza di questi
reciproci rapporti è data però dal cosiddetto Pilastro di Eliodoro.
Nella città di Besnagar o Vidiṣa è conservato un pilastro con una
scritta in pracrito da cui si desume che esso fu eretto da un greco, di
nome Eliodoro figlio di Dione, che era stato inviato alla corte del re
Śuṅga Bhāgabhadra per conto del re indo-greco
Antalcida (110-100 a.C. circa)
[81]. La cosa più interessante
è che il pilastro, che, a quanto risulta dall’iscrizione, doveva essere
sormontato da un Garuḍa
[82], è in onore di Vāsudeva
(Viṣṇu) e
che Eliodoro definisce sé stesso come un Bhāgavata, vale a dire
come appartenente a un movimento religioso di intonazione viṣṇuita che
pone come principio essenziale della vita religiosa la bhakti,
cioè la devozione personale a una divinità. Il movimento si andava
sviluppando proprio allora (anche se gli aderenti amavano retrodatare
di circa tre secoli l’origine della dottrina) ed ebbe influssi anche
sul buddhismo, in parallelo con la tendenza sempre più vigorosa nel
buddhismo dell’epoca a fare del Buddha una vera e propria divinità. Ciò
dimostra che, per quanto le fonti parlino prevalentemente di greci
sensibili al fascino del buddhismo, non mancarono comunque adesioni
anche alla linea religiosa brahmanico-induista
[83].
La migliore testimonianza di questi
reciproci rapporti è data però dal cosiddetto Pilastro di Eliodoro.
Nella città di Besnagar o Vidiṣa è conservato un pilastro con una
scritta in pracrito da cui si desume che esso fu eretto da un greco, di
nome Eliodoro figlio di Dione, che era stato inviato alla corte del re
Śuṅga Bhāgabhadra per conto del re indo-greco
Antalcida (110-100 a.C. circa)
[81]. La cosa più interessante
è che il pilastro, che, a quanto risulta dall’iscrizione, doveva essere
sormontato da un Garuḍa
[82], è in onore di Vāsudeva
(Viṣṇu) e
che Eliodoro definisce sé stesso come un Bhāgavata, vale a dire
come appartenente a un movimento religioso di intonazione viṣṇuita che
pone come principio essenziale della vita religiosa la bhakti,
cioè la devozione personale a una divinità. Il movimento si andava
sviluppando proprio allora (anche se gli aderenti amavano retrodatare
di circa tre secoli l’origine della dottrina) ed ebbe influssi anche
sul buddhismo, in parallelo con la tendenza sempre più vigorosa nel
buddhismo dell’epoca a fare del Buddha una vera e propria divinità. Ciò
dimostra che, per quanto le fonti parlino prevalentemente di greci
sensibili al fascino del buddhismo, non mancarono comunque adesioni
anche alla linea religiosa brahmanico-induista
[83].
Con l’avvento del Cristianesimo è possibile che sia iniziata una nuova epoca di rapporti tra il mondo occidentale e l’India. Una diffusa tradizione parla dell’evangelizzazione dell’India da parte dell’apostolo Tommaso: in realtà né le fonti neotestamentarie né le fonti storiche immediatamente successive dànno indicazioni che possano in qualche modo confermare questa notizia. Secondo Eusebio (Hist. eccles. III 1, 1) Tommaso predicò il Vangelo in Siria e in Persia, ma non vi sono notizie circa una sua predicazione in zone più orientali. È però probabile che fossero sorte comunità cristiane in India, grazie all’attività evangelizzatrice dei cristiani presenti in medio Oriente e nell’area dell’impero persiano, come mostrerebbero alcune antiche iscrizioni in pahlavi ritrovate in India [84]. La predicazione di Tommaso in India è narrata da un libro apocrifo, pervenutoci in una redazione greca e in una siriaca, gli Acta Thomae, un testo di origine gnostica: benché l’ammassarsi di elementi fantastici, come in tutti gli apocrifi, rendano ogni parola del libro sospetta e inutilizzabile per la ricostruzione storica, la narrazione propone una buona conoscenza di luoghi e di personaggu, così da rendere proponibile l’ipotesi che nei primi secoli dell’era cristiana vi fosse una presenza, più o meno estesa, di comunità cristiane nell’India settentrionale. A questa origine difficilmente può essere riportata la cosiddetta “Chiesa di Malabar” [85] (nonostante il titolo di “Figli di San Tommaso” con cui gli amano chiamarsi i cristiani nella zona che va dall’Iraq all’India), perché di fatto la sua origine non sembra anteriore al VI secolo.
Gli Acta Thomae sono, nella redazione greca, una narrazione di non grande estensione (171 capitoli): la sua redazione può essere collocata, secondo gli studiosi, in Siria attorno al 220 d.C.: alcuni (Harnack) fanno anche il nome preciso di Bardesane come autore del testo. Il libro comincia con la narrazione dell’estrazione a sorte con cui gli Apostoli si erano suddivisi le zone del mondo in cui portare la predicazione del Vangelo. A Tommaso era toccata l’India, ma l’apostolo dichiara la sua inferiorità rispetto a un simile compito e rinuncia ad andare, nonostante che la notte seguente gli fosse apparso in sogno Gesù stesso che lo invitava ad andare in India. Nel frattempo però si trovava in Gerusalemme un certo Abbane, inviato del re Gundaforo (in realtà Gondophares o forse Gundophernes [86], il primo re della dinastia indo-partica che regnò su un vasto territorio dell’India settentrionale, dall’Himalaya fino al Balucistan e al Sindh, in un periodo circa dal 21 al 47 d.C.), che era stato inviato per procurare un falegname. Mentre si trovava nella piazza della città all’ora del mezzogiorno il Signore si avvicinò a lui e, indicandogli Tommaso che si trovava poco discosto, stabilì con lui un contratto che poneva Tommaso al suo servizio [87]. I due partono alla volta dell’India e giungono ad Andrapoli, dove stanno svolgendosi le nozze della figlia del re: ma in conseguenza di una serie di avvenimenti Tommaso alla fine esorta la figlia del re a rimanere vergine. In séguito Tommaso giunge da Gundaphoros e attende alla costruzione del palazzo regale, ma usa il denaro datogli dal re per aiutare i poveri. Il re lo fa imprigionare, ma Tommaso fugge miracolosamente, e gli avvenimenti che si susseguono sono talmente prodigiosi, che il re decide di convertirsi al Cristianesimo. Nella parte successiva del testo Tommaso si reca nella città del re Misdai e ne converte la moglie Terza, poi il racconto prosegue con un dispiegamento di fatti soprannaturali e di creature romanzesche (draghi e asini selvatici), fino alla conclusione in cui l’apostolo subisce il martirio.
II. Rapporti culturali
1. Le arti figurative.
Nelle arti figurative gli influssi culturali sono numerosi e agiscono in entrambe le direzioni: vi sono monete greche in cui compaiono in modo sempre più palese influssi indiani (generalmente buddhisti) e vi sono opere d’arte indiane in cui compaiono influssi greci o addirittura sono raffigurate divinità o personaggi mitici della Grecia. Si tratta di fatti ben noti, sui quali l’indagine degli studiosi occidentali si è esercitata in profondità fin dalla fine del XIX secolo e sui quali esiste una bibliografia abbondante. Non entreremo dunque nel merito del discorso, accontentandoci di qualche scarna indicazione.
a. Influssi buddhisti nelle monete dei re indo-greci. Si è accennato prima alla raffigurazione di divinità del pantheon greco nelle monete dei re indo-greci. Non mancano però monete con motivi più o meno direttamente tratti dalla tradizione indiaba. Agatocle, uno dei successori di Demetrio, fa coniare monete di forma quadrata in cui appaiono su uno dei lati il leone (simbolo buddhista) e sull’altro la dea indiana Lakṣmī. Il cakravarta o ruota della legge compare in monete dell’età di Menandro. E sempre a partire da Menandro appare anche sulle monete la denominazione del sovrano come dharmika ‘seguace del dharma’, intesa come equivalente della titolatura greca δίκαιος: infatti in una moneta di Menandro la scritta in pracrito Mahārājasa dhramikasa Menadrasa è la versione indiana della scritta greca che compare sull’altra faccia βασιλεωσ δικαιου μενανδρου.
b. Influssi greci. Le prime statue del Buddha non sono anteriori al II-I sec. a.C. (in precedenza l’arte buddhista si limitava a rappresentazioni simboliche e non antropomorfe), e vari indizi fanno pensare alla presenza di influs si della statuaria greco-ellenistica. Una tradizione buddhistica cinese afferma che la prima statua del Buddha venne creata nel 43 a.C. a PaĘaliputra per iniziativa di Nāgasena: si tratta del famoso Buddha di smeraldo oggi conservato a Bangkok [88]. Poiché Nāgasena è presentato come il maestro che convertì Menandro al buddhismo nel Milindapañha, è abbastanza facile concludere che nell’ambito del regno indo-greco si dovette sviluppare una tendenza artistica che spinse a rappresentare il Buddha secondo gli stilemi propri della cultura ellenistica. Secondo V. Pisani, che aveva proposto di vedere in rappresentazioni indiane di Apsaras (le ninfe celesti della religione brahmanica), un adattamento o una continuazione del Ganimede di Leocare, la regione indiana del Gandhāra «offre lo spettacolo di una scultura ellenistica soltanto lievemente indianizzata» [89]. Come conferma Tarn [90], il Gandhāra è «a kind of new Hellas» [91].
2. Scienze.
Il peso dell’influsso greco nell’ambito scientifico (e in modo particolare nell’astronomia) è rilevante e riconosciuto dalla stessa tradizione indiana. Benché non mancassero, fin dai testi vedici più antichi, prove dell’interesse degli Indiani per l’osservazione e la descrizione dei fenomeni celesti, il primo trattato sistematico sull’argomento è un’opera la cui ascendenza greca è rivelata già dal titolo di Yavanajātaka (“I detti dei Greci”); si tratta della ripresa di un’opera greca scritta in Egitto attorno alla fine del II sec. a.C. e tradotta attorno al 150 d.C. da un personaggio dal nome trasparente di Yavaneśvara (‘signore dei Greci’). Successivamente il materiale fu rielaborato e ridotto in versi. Altre opere di astronomia e astrologia riconducibili a modelli greci sono la Paulisa Siddhānta (‘Dottrina di Paolo), traduzione in sanscrito dell’opera astronomica di Paolo di Alessandria (IV sec. d.C.) e la Romāka Siddhānta (‘Dottrina dei Romani’) un’opera di astronomia basata su trattati occidentali (‘Romani’). Queste opere ebbero un influsso importante sullo sviluppo di un pensiero scientifico locale che a sua volta diede poi luogo, attraverso la mediazione araba, a influenze anche importanti sulla scienza occidentale. Non si dimentichi che siamo debitori alla scienza indiana delle cifre che usiamo oggi abitualmente, perché quelle che chiamiamo “cifre arabe” in realtà furono inventate dagli Indiani, e da qui passate nel mondo occidentale attraverso la mediazione araba.
|
१ ١ 1 |
२ ٢ 2 |
३ ٣ 3 |
४ ٤ 4 |
५ ٥ 5 |
६ ٦ 6 |
७ ٧ 7 |
८ ٨ 8 |
९ ٩ 9 |
१० ١٠ 10 |
Cifre indiane (riga superiore), arabe e latine
Secondo la prassi corrente di mitizzare l’origine dei fatti umani, si disse che la scienza astronomica «fu rivelata dal Sole stesso agli Yavana (...), quando questo dio, esule del cielo, s’era rifugiato in Romakaputra “la città dei Romani”» [92]. Come si vede, anche la mitizzazione della vicenda non esclude comunque una priorità dei Greci nell’invenzione di questa scienza.
3. Letteratura
Se il debito dell’India nei confronti del mondo occidentale è facile da definire quando si parla dell’arte e delle osservazioni scientifiche, assai più problematico da precisare è l’influsso che le lettere greche possono avere avuto sullo sviluppo della letteratura indiana.
E’ stato notato [93] che alcuni termini indicanti il materiale scrittorio sono prestiti greci (mala ‘inchiostro’ < gr. μέλας, kalama ‘penna’ < gr. κάλαμος ‘canna’), il che starebbe a indicare un prestigio della lingua greca (e quindi della cultura greca) in questo particolare settore del lessico.
Ma, più che questi aspetti, importanti, ma pur sempre esterni rispetto alle vicende dello sviluppo culturale di una nazione, è degno di considerazione il momento storico in cui i rapporti tra Grecia e India si fecero più stretti e sistematici. Attorno al IV secolo la cultura indiana si sta preparando a un cambiamento significativo, col passaggio dalla fase vedica alla fase classica. È un passaggio che non coinvolge solamente la lingua, ma va alle radici stesse della letteratura indiana. Non esiste una discontinuità assoluta tra questi due momenti: in India tutto può cambiare, ma non si hanno mai (o quasi mai) momenti di rottura brusca tra due fasi: nella religione si arriva dal Veda al brahmanesimo e poi all’induismo senza che vi siano stati mai né stacchi traumatici né una sconfessione aperta della fase precedente. Come da un punto di vista linguistico il sanscrito non è la continuazione diretta del vedico, ma non potrebbe esistere senza il vedico, così la letteratura sanscrita classica è qualcosa di profondamente diverso dalla letteratura vedica per la sua varietà e per la sua ricchezza, ma non potrebbe neppure concepirsi senza quest’ultima. La differenza fondamentale tra i due momenti è costituita principalmente dal fatto che la tradizione letteraria vedica presenta esclusivamente testi di interesse religioso: o i testi sacri nel senso stretto del termine (i Veda, che costituiscono la śruti o rivelazione [94]) o testi che servono comunque di accompagnamento a questi: opere che hanno finalità didattiche o pratiche, o riflessioni teologiche o filosofico-teologiche che s’impegnano nell’approfondimento di contenuti e dottrine dei testi vedici, immancabilmente considerati base imprescindibile della vita brahmanica. La letteratura dell’India classica è invece una letteratura esuberante e dai mille aspetti, nella quale fiorisce ogni genere letterario con una grandissima quantità di testi profani. La crisi e l’esaurimento della letteratura post-vedica coincide, nel VI sec. a.C., col rapido diffondersi tra le masse delle due religioni eterodosse (buddhismo e jainismo). Parallelamente al propagarsi delle nuove fedi si assiste all’iniziarsi di una nuova tradizione letteraria, che di preferenza fa uso delle lingue pracrite, sia pure in una forma colta e adattata all’uso letterario: il pāli è la lingua fondamentale del canone buddhista, l’ardhamāgadhī (o una lingua ibrida e artificiale a cui è dato il nome di arṣa ‘la lingua dei veggenti [ṛṣi]’) è la lingua del canone jainista. La scelta di valorizzare non più la lingua della tradizione post-vedica, bensì la lingua (o le lingue) dell’uso corrente è dovuta anche alla volontà di permettere una più vasta diffusione nelle masse dei testi delle nuove dottrine: una scelta che ha più di un’analogia con quanto avvenne nel Cristianesimo primitivo, che non si avvalse (almeno all’inizio) del latino ciceroniano, ma utilizzò una lingua più vicina a quella dell’uso corrente, con l’introduzione di fatti volgari (soprattutto nel lessico), in misura proporzionale non solo alla cultura di chi scriveva (le prime versioni della Bibbia, opere spesso pioneristiche di persone che avevano una conoscenza appena superficiale del latino, contengono un numero impressionante di volgarismi a ogni livello della lingua, fonetica, morfologia e sintassi), ma anche alle precise scelte stilistiche dello scrivente (un personaggio di cultura immensa come Agostino utilizza nei suoi Sermones forme del latino volgare, per rendere più diretta e naturale la sua comunicazione col popolo cristiano).
Tra il IV e il II sec. a.C. il sanscrito tende a riaffermarsi come lingua della cultura e della letteratura. Questa ripresa del sanscrito (“Sanskrit-Renaissance” la chiamarono gli studiosi tedeschi del XIX secolo) è contemporanea al rinvigorirsi della linea tradizionale vedico-brahmanica. Il recupero e il rinnovato slancio di questa è anche dovuto all’evidente impossibilità del buddhismo di adattarsi ad alcuni dei fondamenti indiscussi dell’organizzazione sociale dell’India: c’è un’insanabile discrasia tra buddhismo e organizzazione castale della società, e poiché quest’ultima permea in modo profondo la coscienza stessa dell’India, alla fine l’impossibilità di addivenire a una sintesi tra buddhismo e caste finisce per frenare la diffusione del buddhismo nella società stessa. La contemporaneità tra ripresa del sanscrito e ripresa del brahmanesimo dunque non è casuale. L’abbattimento dell’impero Maurya e la sua sostituzione con una dinastia che favorisce la religione brahmanica è indizio di questo diverso orientamento che la società indiana sta assumendo.
La nascita di una letteratura profana in sanscrito è forse preceduta da una breve fioritura di una letteratura profana in lingue volgari, rappresentata soprattutto dalla poesia lirica, e favorita dal fatto che buddhismo e jainismo avevano permesso la circolazione dei pracriti: Hāla attorno al II sec. d.C. raccoglie un’antologia di brevi componimenti lirici (in tutto settecento), sintesi della produzione accumulatasi nei secoli precedenti. Esauritasi questa breve esperienza, il sanscrito ridiventa la lingua comune della cultura dell’India, una lingua che non è destinata solamente alla poesia e alla prosa artistica, perché, presentandosi come il raggiungimento della perfezione [95], diventa anche simbolo di unità culturale e di prestigio sociale nel medesimo tempo (non per nulla nel dramma il sanscrito è la lingua degli uomini delle caste superiori e delle divinità maschili, mentre in pracrito parlano gli uomini delle caste inferiori e gli esseri di sesso femminile, donne e dee): è una lingua standardizzata con un rigore crescente, che mostra ricchezze di forma, duttilità nella sintassi e potenzialità espressive pressoché inesauribili, e che trae il suo prestigio anche dal fatto di essere la lingua della tradizione religiosa.
La normalizzazione del sanscrito è opera di una tradizione grammaticale che ha il suo massimo rappresentante in Pāṇini, il quale riassume i precetti fondamentali della lingua in una poderosa opera di otto libri (AṣĘādhyāyī ‘Il testo delle otto lezioni’) scritta in uno stile che nella sua brevità e formalizzazione rasenta l’esoterico. Pāṇini vive attorno al IV secolo a.C., e il suo insegnamento è ripreso e reso definitivo dai grammatici delle generazioni successive. A quest’epoca i Greci hanno fatto la loro comparsa ben oltre i confini dell’India, e Pāṇini ne conosce la scrittura, e forse addirittura la usa [96]. Quanto possa aver influito sulla nascita di una fiorente letteratura profana e sull’affermarsi di una lingua nazionale il loro modello, è domanda destinata a non avere risposta, o quanto meno a non avere una risposta certa ed univoca. Certo molti parallelismi dovrebbero far pensare (e cio sembra francamente semplicistica la risposta sbrigativamente negativa di quanti vedono nello svolgimento della letteratura e del pensiero indiano il risultato di un’evoluzione avvenuta tutta all’interno, senza influssi stranieri). Anche nell’Ellenismo si era imposta una lingua nazionale, comune a tutto il vasto territorio che Alessandro aveva acquisito alla Grecità, anche nell’Ellenismo questa lingua nazionale aveva soppiantato nel giro di pochi secoli una serie di parlate locali fortemente differenziate fra loro e aveva assunto un carattere di fissità pressoché assoluta, nel quale vengono dissimulati gli inevitabili cambiamenti che si producono nella varietà parlata; anche nell’Ellenismo si hanno interessi grammaticali e filologici che spingono a uno studio in profondità delle strutture grammaticali. Certo l’Ellenismo poteva mostrare alla letteratura dell’India, la cui creatività era rimasta fin allora ristretta, come detto, all’ambito di testi didascalici al servizio della tradizione sacra, una tradizione letteraria in cui una molteplicità di generi letterari si accordava con una varietà pressoché sconfinata di toni e di argomenti.
Il primo grande poema epico della tradizione indiana è il Rāmāyaṇa ‘Il viaggio di Rāma’, un lungo poema che nella sua redazione attuale consta di sette libri per un totale di 24.000 śloka (strofe) (ma l’inserzione di materiale non autentico, e in particolare l’aggiunta dei libri iniziale e finale, può essere data per certa). Il poema è opera del poeta-veggente (ṛṣi) Vālmīki, e la data della sua composizione potrebbe essere, con oscillazioni e incertezze, quella del IV sec. a.C. Per quanto il poema sia completamente immerso nel quadro della tradizione culturale indiana e contenga elementi impensabili nella tradizione omerica (p.es la costante e insistita presenza di animali antropomorfi, in rapporti ora di collaborazione ora di ostilità nei confronti dei protagonisti umani dell’opera), ci si è chiesti se la spinta alla composizione del poema non sia giunta dalla conoscenza della tradizione epica greca: se certe scelte stilistiche (per esempio i lunghi colloqui tra personaggi) sono aspetti comuni che potrebbero anche non essere legati a una conoscenza diretta del testo omerico, in quanto elementi innati e caratteristici di tutte le tradizioni epiche, assai più interessante è il ricorrere in Vālmīki di aggettivi ricorrenti stabilmente legati a determinati sostantivi e spesso collocati in posizioni fisse del verso. La notizia, fornita da Dione Crisostomo, che i poemi omerici avessero avuto circolazione in India, cosicché gli abitanti di quelle lontane regioni non potevano vedere l’Orsa maggiore, ma potevano conoscere le vicende di Priamo e di Andromaca, potrà essere esagerata in alcuni particolarei, ma difficilmente può essere liquidata come pura e semplice fantasia senza alcun fondamento [97].
Neppure il buddhismo si sottrasse al fascino dell’epica. La più antica biografia del Buddha è narrata in un poema epico (il Buddhacarita ‘Le gesta del Buddha’ di Aśvaghoṣa) o piuttosto epico-lirico. Il poeta, che pure è un devoto della dottrina buddhista, racconta le vicende della vita del Buddha in modo intenso e poeticamente vivace (al di là delle difficoltà linguistiche e stilistiche che rendono estremamente ardua la lettura dell’opera), senza alcun impaccio o appesantimento di natura didascalica, esaltando anzi certe scene in cui prevale il tono lirico e non disdegnando neppure qualche spunto erotico. La data della composizione del Buddhacarita è difficile da stabilire, ma sicuramente posteriore alla composizione del Rāmāyaṇa.
Ma non soltanto la grande epica mostra convergenze coi modelli greci. Uno sguardo alla letteratura dei secoli seguenti ci pone di fronte altre possibilità di contatto. Se leggendo certe espressioni della lirica indiana (per esempio la Centuria di Amaru o l’antologia di Hāla) è difficile resistere alla tentazione di richiamare la poesia epigrammistica del periodo ellenistico, di fronte a certi gioielli di poemetti artistici di argomento mitologico (il Meghadūta o Nuvolo messaggero di Kālidāsa, per dirne uno) è doveroso chiederci se il genere dell’epillio non abbia fatto una sua comparsa in India.
Per ciò che concerne la prosa, i rapporti tra la narrativa indiana e il tipo della fabula Milesia e poi del romanzo sono stati indagati in profondità, con risultati che hanno portato in entrambe le direzioni. Secondo l’ipotesi che uno studioso francese, Félix Lacôte, avanzò all’inizio del XX secolo, la narrativa come genere letterario autonomo nacque e si sviluppò in Grecia sotto l’influsso della narrativa indiana. Purtroppo il nostro giudizio è gravemente limitato dalla perdita dell’originale di quello che dovrebbe essere considerato l’archetipo e il modello per il successivo sviluppo della narrativa indiana, cioè la Bṛhatkathā (‘Grande racconto’) di Guṇaḍhya [98], della quale possiamo conoscere a grandi linee il contenuto solamente attraverso successive rielaborazioni. Il romanzo doveva contenere le vicende del re dei Vatsa Udayana e dei suoi matrimoni con Vāsavadattā e Padmavatī: ma nel racconto principale, riferito in prima persona da un testimone oculare degli eventi, si inserivano una quantità di episodi e di narrazioni, in parte anche raccontate dai vari personaggi, così che il racconto principale finisce per divenire spesso un racconto cornice, sovrastato dalla crescente esuberanza dei racconti secondari: una tecnica che conosciamo bene da opere come le Metamorfosi di Apuleio e altri romanzi della tradizione greca. Questa tecnica divenne poi usuale nella narrativa indiana, al punto che il racconto principale finì per avere un carattere sempre più esile e ad essere relegato sempre più sullo sfondo, divenendo un semplice pretesto narrativo, mentre l’attenzione del lettore era focalizzata soprattutto sul susseguirsi delle varie narrazioni (così nella favolistica, p.es. il Pañcatantra, o nella novellistica, p.es. il Kathāsaritsāgara ‘Oceano dei fiumi di racconti’). Se il Lacôte cercò di dimostrare l’esistenza di una filiazione dall’India alla Grecia in questo particolare settore dell’attività letteraria, altri puntarono piuttosto a dimostrare che era stata la Grecia a fare da modello all’India [99].
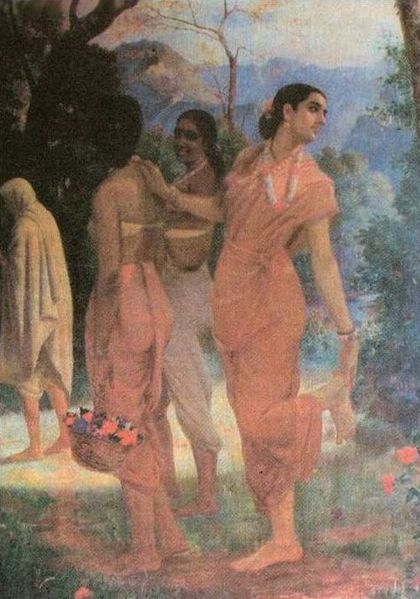 Ma è nel teatro che alcuni hanno pensato di
potere percepire in modo più consistente il modello greco. Se ci furono
insediamenti Greci in India, ci furono anche rappresentazioni di drammi
greci in India. Non è pensabile che, tra tutti i Greci, solo i Greci
che abitavano in India rinunciassero alle rappresentazioni di drammi o
ai festival drammatici
[100]. Del resto, i drammi
greci erano rappresentati anche al di fuori dell’ambito culturale greco
se, come ci attesta Plutarco
[101], la testa di Crasso dopo
la battaglia di Carre poté essere usata a Susa come appropriato
attrezzo scenico per una rappresentazione delle Baccanti di
Euripide. Siamo alla corte regale dei Parti, non siamo nel mondo greco,
ma anche qui la produzione teatrale greca evidentemente è conosciuta e
viene apprezzata. Del fatto che il teatro greco, e in particolare le
tragedie di Sofocle, fosse noto in India abbiamo la certezza
documentaria: a Peshawar è stato trovato un frammento di vaso (oggi
conservato nel museo di Lahore) fabbricato in loco
sul quale è rappresentata una scena dell’Antigone (Emone che
prega Creonte di non condannare a morte Antigone). Secondo quanto
notava Weber, nell’esercito di Alessandro c’erano mimi, giocolieri,
artisti da circo, che Alessandro intendeva usare come “mezzo per
l’ellenizzazione dell’Oriente”
[102]. Tra dramma indiano e
commedia nuova sembrano sussistere dei legami. Non è solamente la
presenza delle
yavanī, le raffinate danzatrici greche (o forse rinomate etere, da
cui le colleghe indiana, a quanto pare, avrebbero avuto molto da
imparare) che nei drammi di Kālidāsa fan sempre parte del séguito del
re, o il fatto che
yavanikā ‘greca’ sia il nome dato al tendaggio che fa da sfondo
alla scena, a motivare questa impressione. Sta di fatto che sia la
nea sia il dramma indiano hanno una consonanza singolare nella
formulazione degli intrecci: le vicende amorose di una coppia, che per
una qualunque motivo si separa, le peripezie che portano allo
scioglimento dell’azione e al ritrovarsi dei due amanti, e soprattutto,
spesso il riconoscimento dell’identità dell’altro per mezzo di un
oggetto che era stato smarrito. Anche la presenza di personaggi fissi
che presentano caratteristiche somiglianti (p.es. lo schiavo della
commedia greco-romana e il vidūṣaka,
un brahmano compagno di sollazzi, e soprattutto di pranzi, del
protagonista) è un’altra coincidenza importante
[103]. Nella Śakuntalā
riconosciuta di Kālidāsa, per citare il più apprezzato esempio di
dramma indiano e il più noto anche nella tradizione occidentale,
l’oggetto indispensabile per il riconoscimento è l’anello che il re Duėyanta
aveva lasciato alla donna nel momento di allontanarsi da lei e che
viene perso durante un’abluzione rituale, così che la donna non può
opporre all’amante, immemore di lei per le conseguenze di una
maledizione, lo strumento che farebbe cadere il velo d’oblio che gli
offusca la memoria: l’anello ricomparirà in séguito, pescato nel ventre
di un pesce, e la sua vista riporterà alla memoria del re l’episodio
della donna che ha colpevolmente abbandonato insieme col bambino che
aveva in seno. La conclusione positiva (dal momento che il dramma
indiano presuppone sempre una conclusione positiva e aborrisce
qualunque situazione violenta o sanguinosa) avverrà in questo caso per
altra via. Ma si è visto che anche nel Mudrārakṣasa,
che pure ha una posizione anomala nella storia del teatro indiano, è
l’anello col sigillo del ministro, perso dalla sua consorte, a
costituire il fulcro essenziale della trama. Sarebbe indubbiamente
semplicistico e riduttivo attribuire semplicemente all’imitazione del
teatro greco la nascita di una tradizione teatrale in India
[104]. Altre ipotesi sono
state fatte: dal progressivo sviluppo di situazioni dialogate quali si
hanno fin dagl’inni vedici, alla crescente popolarità di un teatro di
ombre o di un teatro di marionette che si svolge sulle pubbliche
piazze, alle rappresentazioni di mimi. Senza pervenire a conclusioni
eccessive, si può benissimo pensare a un’azione catalizzatrice che il
dramma greco poté avere sul nascente teatro indiano. Tra i più antichi
autori di drammi si annoverano il già citato Aśvaghoṣa
e Bhāṣa: autore di drammi
apprezzati e citati nel periodo antico (Kālidāsa lo nomina
espressamente come uno dei suoi predecessori), quest’ultimo ha
conosciuto un lungo periodo d’oblio, e solamente all’inizio del XX
secolo sono tornati alla luce alcuni dei suoi drammi. Purtroppo
l’impossibilità di determinare delle coordinate cronologiche precise
(per Bhāṣa si suppone un’epoca che va dal II sec. a.C. al II sec. d.C.)
non consente neppure di stabilire se tra la definitiva maturazione del
teatro indiano e la presenza dei Greci in India c’è o meno un rapporto
cronologico. L’ipotesi dell’influsso greco fu formulata fin dalle prime
stampe occidentali della Śakuntalā di Kālidāsa: Weber nel
1851, poi Windisch nel Congresso degli Orientalisti tenutosi a Berlino
nel 1881, poi altri studiosi avevano osservato alcune coincidenze tra
dramma indiano e la commedia nuova; l’ipotesi poi trovò sempre meno
consenso tra gli studiosi
[105]. Se si potesse in
qualche modo avvalorare la tesi di Lévi, secondo cui la forma
definitiva del dramma indiano sarebbe stata fissata a Mathurā nel I
sec. a.C.
[106], l’ipotesi di un
influsso greco sulla nascita del teatro indiano farebbe un grosso balzo
in avanti. Purtroppo questa ipotesi, benché affascinante, ha poche
probabilità di essere provata in modo definitivo, e così il problema
del possibile rapporto greco continua ad essere, per chi si pone nella
prospettiva dell’India, nient’altro che una questione irritante
[107].
Ma è nel teatro che alcuni hanno pensato di
potere percepire in modo più consistente il modello greco. Se ci furono
insediamenti Greci in India, ci furono anche rappresentazioni di drammi
greci in India. Non è pensabile che, tra tutti i Greci, solo i Greci
che abitavano in India rinunciassero alle rappresentazioni di drammi o
ai festival drammatici
[100]. Del resto, i drammi
greci erano rappresentati anche al di fuori dell’ambito culturale greco
se, come ci attesta Plutarco
[101], la testa di Crasso dopo
la battaglia di Carre poté essere usata a Susa come appropriato
attrezzo scenico per una rappresentazione delle Baccanti di
Euripide. Siamo alla corte regale dei Parti, non siamo nel mondo greco,
ma anche qui la produzione teatrale greca evidentemente è conosciuta e
viene apprezzata. Del fatto che il teatro greco, e in particolare le
tragedie di Sofocle, fosse noto in India abbiamo la certezza
documentaria: a Peshawar è stato trovato un frammento di vaso (oggi
conservato nel museo di Lahore) fabbricato in loco
sul quale è rappresentata una scena dell’Antigone (Emone che
prega Creonte di non condannare a morte Antigone). Secondo quanto
notava Weber, nell’esercito di Alessandro c’erano mimi, giocolieri,
artisti da circo, che Alessandro intendeva usare come “mezzo per
l’ellenizzazione dell’Oriente”
[102]. Tra dramma indiano e
commedia nuova sembrano sussistere dei legami. Non è solamente la
presenza delle
yavanī, le raffinate danzatrici greche (o forse rinomate etere, da
cui le colleghe indiana, a quanto pare, avrebbero avuto molto da
imparare) che nei drammi di Kālidāsa fan sempre parte del séguito del
re, o il fatto che
yavanikā ‘greca’ sia il nome dato al tendaggio che fa da sfondo
alla scena, a motivare questa impressione. Sta di fatto che sia la
nea sia il dramma indiano hanno una consonanza singolare nella
formulazione degli intrecci: le vicende amorose di una coppia, che per
una qualunque motivo si separa, le peripezie che portano allo
scioglimento dell’azione e al ritrovarsi dei due amanti, e soprattutto,
spesso il riconoscimento dell’identità dell’altro per mezzo di un
oggetto che era stato smarrito. Anche la presenza di personaggi fissi
che presentano caratteristiche somiglianti (p.es. lo schiavo della
commedia greco-romana e il vidūṣaka,
un brahmano compagno di sollazzi, e soprattutto di pranzi, del
protagonista) è un’altra coincidenza importante
[103]. Nella Śakuntalā
riconosciuta di Kālidāsa, per citare il più apprezzato esempio di
dramma indiano e il più noto anche nella tradizione occidentale,
l’oggetto indispensabile per il riconoscimento è l’anello che il re Duėyanta
aveva lasciato alla donna nel momento di allontanarsi da lei e che
viene perso durante un’abluzione rituale, così che la donna non può
opporre all’amante, immemore di lei per le conseguenze di una
maledizione, lo strumento che farebbe cadere il velo d’oblio che gli
offusca la memoria: l’anello ricomparirà in séguito, pescato nel ventre
di un pesce, e la sua vista riporterà alla memoria del re l’episodio
della donna che ha colpevolmente abbandonato insieme col bambino che
aveva in seno. La conclusione positiva (dal momento che il dramma
indiano presuppone sempre una conclusione positiva e aborrisce
qualunque situazione violenta o sanguinosa) avverrà in questo caso per
altra via. Ma si è visto che anche nel Mudrārakṣasa,
che pure ha una posizione anomala nella storia del teatro indiano, è
l’anello col sigillo del ministro, perso dalla sua consorte, a
costituire il fulcro essenziale della trama. Sarebbe indubbiamente
semplicistico e riduttivo attribuire semplicemente all’imitazione del
teatro greco la nascita di una tradizione teatrale in India
[104]. Altre ipotesi sono
state fatte: dal progressivo sviluppo di situazioni dialogate quali si
hanno fin dagl’inni vedici, alla crescente popolarità di un teatro di
ombre o di un teatro di marionette che si svolge sulle pubbliche
piazze, alle rappresentazioni di mimi. Senza pervenire a conclusioni
eccessive, si può benissimo pensare a un’azione catalizzatrice che il
dramma greco poté avere sul nascente teatro indiano. Tra i più antichi
autori di drammi si annoverano il già citato Aśvaghoṣa
e Bhāṣa: autore di drammi
apprezzati e citati nel periodo antico (Kālidāsa lo nomina
espressamente come uno dei suoi predecessori), quest’ultimo ha
conosciuto un lungo periodo d’oblio, e solamente all’inizio del XX
secolo sono tornati alla luce alcuni dei suoi drammi. Purtroppo
l’impossibilità di determinare delle coordinate cronologiche precise
(per Bhāṣa si suppone un’epoca che va dal II sec. a.C. al II sec. d.C.)
non consente neppure di stabilire se tra la definitiva maturazione del
teatro indiano e la presenza dei Greci in India c’è o meno un rapporto
cronologico. L’ipotesi dell’influsso greco fu formulata fin dalle prime
stampe occidentali della Śakuntalā di Kālidāsa: Weber nel
1851, poi Windisch nel Congresso degli Orientalisti tenutosi a Berlino
nel 1881, poi altri studiosi avevano osservato alcune coincidenze tra
dramma indiano e la commedia nuova; l’ipotesi poi trovò sempre meno
consenso tra gli studiosi
[105]. Se si potesse in
qualche modo avvalorare la tesi di Lévi, secondo cui la forma
definitiva del dramma indiano sarebbe stata fissata a Mathurā nel I
sec. a.C.
[106], l’ipotesi di un
influsso greco sulla nascita del teatro indiano farebbe un grosso balzo
in avanti. Purtroppo questa ipotesi, benché affascinante, ha poche
probabilità di essere provata in modo definitivo, e così il problema
del possibile rapporto greco continua ad essere, per chi si pone nella
prospettiva dell’India, nient’altro che una questione irritante
[107].
Conclusione.
La vicenda del regno indo-greco è relativamente breve, in rapporto ai tempi e alla scansione della storia (soprattutto di una storia millenaria come quella dell’India), ma fu un’occasione importante per permettere una conoscenza e un incontro più intenso e potenzialmente fruttuoso tra due delle più grandi civiltà che l’umanità abbia avuto. Il regno indo-greco in sostanza è un episodio assolutamente unico nel pur variegata e composita storia della cultura ellenistica. È un capitolo di grande interesse, sia dal punto di vista greco sia dal punto di vista indiano: fu un momento in cui si stabilirono in modo diretto contatti organici tra due tradizioni culturali che avevano alle spalle secoli di riflessione e di saggezza. Il sincretismo che si viene a determinare dà luogo a risultati in buona parte sorprendenti. Purtroppo le nostre conoscenze di questo episodio sono scarse, sia per la difficoltà di relazione e di comunicazione che caratterizzano l’epoca antica sia perché la curiosità e il fascino che molti autori greci mostrano nei confronti delle culture orientali non si traduce poi in una sistematica acquisizione di notizie e pubblicazione di dati. Delle vicende del regno indo-greco, come abbiamo visto, non si hanno che pochi e imprecisi echi nella storiografia e nella pubblicistica greca o greco-latina [108]. Misurare dal punto di vista indiano il peso e l’importanza che la conoscenza dell’elemento greco può avere avuto è difficile. Il fatto che il momento storico in cui quest’incontro tra due grandi culture si verificò più o meno coincida con una fase di grande trasformazione della cultura indiana è certo significativo, anche se la semplice coincidenza cronologica non autorizza certo, in mancanza di dati concreti, a conclusioni eccessivamente impegnative. Certo il regno indo-greco si colloca in una fase di trasformazione tra due epoche della cultura indiana fra le quali intercorrono tratti di notevole diversità culturale e linguistica (segnata quest’ultima dalla diversità vedico ~ sanscrito classico, due fasi che si pongono in una curiosa linea di continuità ~ diversità). È impossibile dire quanto possa avere pesato l’influsso straniero. Anche gli studiosi di linguistica storica, quando si trovano di fronte a cambiamenti e trasformazioni di un sistema, si ritrovano nell’incertezza, dovendo decidere se i cambiamenti sono una semplice evoluzione che avviene sotto la spinta di forze tutte interne al sistema o sono stati favoriti dall’intervento di modelli stranieri. Qui il discorso è ancora più complicato, perché non solo la valutazione, ma la semplice elencazione dei fatti presenta incertezze e lacune non facili da colmare.
Appendice. L’iscrizione di Kandahar
Bibliografia
Berriedale Keith A., Tha Sanskrit Drama. In its Origin, Development, Theory and Practice, Delhi, Motilal Banarsidass, 19982
Boccali G.-Piano S.-Sani S., Le letterature dell’India, Torino, UTET, 2000
Bopearachchi O., Monnaies Gréco-Bactriennes et Indo-Grecques, Catalogue Raisonné, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1991
Falà A.M., Milindapanha. Le domande del re Milinda, Roma, Ubaldini, 1982
Gonda J. (ed.), A History of Indian Literature, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1975 e ss.
Lacôte F., Essai sur Gunadhya et la Brhatkatha, Erneste Leroux, Paris 1908
Narain, A.K., The Indo-Greeks, Oxford, Clarendon Press, 1962 (poi Delhi 1980)
Pisani V., Storia delle letterature antiche dell’India, Milano, Nuova Accademia Editrice, 1959
Ranajit Pal, Non-Jonesian Indology and Alexander, New Delhi, Minerva Press, 2002
Reich H., Der Mimus. Ein litterar-entwickelungsgeschichtlicher Versuch, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1903
Renou L.-Filliozat J., L’Inde classique. Manuel des études indiennes, Paris, École Française d'Extrême Orient, 2005 (ristampa)
Rocher L., The Purāṇas, in J. Gonda (ed.), A History of Indian Literature, vol. II 3, Wiesbaden 1986
Sircar D.C., Aśokan Studies, Calcutta, Indian Museum, 1979
Tarn W.W., The Greeks in Bactria and India, Cambridge University Press, 1951
Vallauri M. (a cura di), Teatro Indiano, Milano, Editrice Nuova Accademia, 1959.
Weber A., Die Griechen in Indien, Berlin, Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1890
Winternitz M., Geschichte der indischen Litteratur, 3 voll., Leipzig, Amelangs Verlag, 1907-1920
Woolner A.C., Asoka [sic] Text and Glossary. Part I: Introduction, Text, Rare Reprints, Delhi, 1982 (rist. ansatatica dell‘ediz. 1924)
[1] «biduum irae datum est» (Curt. Ruf. IX 3, 19).
[2] Arriano, Anabasis VI 1, 4.
[3] Plutarco, Alex. 65.
[4] P.es. Plutarco, Alex. 64; Hist. Alex. Magni, rec. A, I 3, 5.
[5] Strabo XV 1, 65.
[6] Il nome di Alessandro non viene ricordato in India in nessuna fonte antica; solamente in fonti tarde e medievali se ne trova traccia. I tentativi di trovarne qualche traccia (cfr. Weber, pp. 6 ss) sono in genere poco persuasivi.
[7] Nella grande iscrizione di Behistun (l. 16), e anche altrove, facendo l’elenco delle sue province, Dario nomina anche il Gandhāra (la zona nella valle del Cophen, un affluente dell’Indo), insieme all’Aracosia (odierna regione di Kandahār nell’Afghanistan) e ad altre satrapie collocate all’estremo oriente del suo impero. Il possesso della valle del Cophen ha un’importanza strategica, perché permette anche il controllo dell’alta valle dell’Indo. Abbiamo anche notizia di una visita al fatta da Dario nella primavera del 515 a Taxila, che si trovava ad Est dell’Indo, in territorio quindi che non è più Persia, bensì India.
[8] Per le fonti greco-romane sull’India precedenti il periodo di Alessandro cfr. Renou-Filliozat, vol. I, pp. 144 ss.
[9] Anabasis V 1, 2; cfr. anche ps.-Apoll. III 2 (ma il breve passaggio che accenna alla spedizione di Dioniso in India è da ritenere interpolato) e Tzetzes, Chiliades VIII 582 ss.
[10] Anabasis V 1, 6.
[11] «nec non et Nysam urbem plerique Indiae adscribunt montemque Merum, Libero Patri sacrum, unde origo fabulae, Iovis femine editum» (Plin., Nat. Hist. VI 79).
[12] Plut., De sera numinis vindicta 557 B. Sulla vicenda dei Branchidi cfr. anche Strabone XIV 1, 5; Curt. Ruf. VII 5, 28 ss., ecc..
[13] «nullo Macedonum dignante» (Giustino 41, 4, 1).
[14] Diodoro Siculo, XVIII 39, 6. Staganore è il nome del personaggio secondo Giustino (loc. cit.).
[15] Candragupta significa propriamente “luna velata” (candra- ‘luna’, corradicale del lat. candēre e candidus, e gupta-, participio passato passivo di gup- ‘nascondere, celare’). Nel dramma di Viśakhadatta in più occasioni si hanno giochi di parole e allusioni al significato del nome del sovrano.
[16] Yavana è il nome con cui sono chiamati in India i Greci. Si tratta della trascrizione indiana di *iāones, iāwones. Anche in altre lingue orientali (armeno, ebraico, p.es.) il nome degli Ioni è divenuto il nome per antonomasia di tutti i Greci, sia per il maggior prestigio culturale degli Ioni rispetto alle altre stirpi greche sia perché le colonie ioniche d’Asia minore erano le più facilmente accessibili per le popolazioni stanziate a oriente. Il nome yavana è attestato per la prima volta nell’opera del grammatico Pāṇini (IV-III sec. a.C.), che accenna alla yavanānī lipi, la scrittura greca (IV 1, 49).
[17] Potrà sembrare strano, agli specialisti di mondo classico, che ci siano oscillazioni così forti nelle indicazioni delle date di una dramma. La realtà è che la tradizione indiana non ha un concetto di storia equivalente a quello che si è venuto formando nel mondo greco, e quindi l’indicazione delle date, sia degli avvenimenti storici sia (soprattutto) degli avvenimenti collegati con fatti letterari (vita degli autori, date delle composizioni) manca in modo pressoché totale: per datare un’opera letteraria o la vita di un autore si deve ricorrere a termini ante e post quem collegati a fatti esterni al mondo indiano (invasioni, ecc.): quando questi mancano, si deve ricorrere a congetture basate su fattori stilistici o simili, che portano spesso a conclusioni vaghe e puramente indicative.
[18] Le ragazze avvelenatrici sono prostitute che, secondo una credenza indiana, hanno imbevuto il corpo di potenti veleni (rispetto ai quali sono mitridatizzate) e li trasmettono ai loro amanti attraverso il rapporto sessuale.
[19] La tradizione indiana ha grande considerazione per la politica, in quanto parte dell’artha (la ricerca del benessere, che costituisce, insieme col kāma ‘il piacere’ e il dharma ‘il rispetto della legge morale’, uno dei tre scopi [trivarga] dell’uomo indiano, scopi da realizzare ciascuno senza pregiudizio degli altri due e in epoche diverse dell’esistenza). Un importante trattato di politica, l’Arthaśāstra, ci è giunto sotto il nome di Kauṭilya (altro nome del Caṇakya protagonista del nostro dramma), ma si tratta di opera redatta in epoca sicuramente posteriore a quella in cui è vissuto questo personaggio (circa IV sec. d.C.); alle arti della politica sono dedicati molti testi della tradizione favolistica (a partire dal Pañcatantra) e vari passaggi in opere della tradizione epica, quali il Mahābhārata.
[20] Del dramma esiste un’ottima traduzione italiana di M. Vallauri, che si può leggere nel volume (da lui curato) Teatro indiano.
[21] Vita Alexandri 62.
[22] Gli śūdra costituivano la casta più bassa della popolazione indiana: erano probabilmente discendenti delle popolazioni indigene incontrate e sottomesse dagli Ari quando erano giunti nel subcontinente indiano da Nord-Ovest e avevano esteso il loro dominio man mano verso sud. Le altre tre caste erano costituite dai brāhmaṇa- (la casta sacerdotale), dagli kṣatriya- (la casta guerriera, dal cui seno aveva normalmente origine il re) e dai vaiśya- (la ‘gente del villaggio’, i ‘borghesi’). Come si vede, le tre caste (in sanscrito varṇa- ‘colore’) corrispondono alle tre funzioni di Dumézil. In séguito, anche come conseguenza dei numerosi matrimoni intercastali e di un’accentuata specializzazione in base al mestiere esercitato, l’organizzazione castale divenne più complessa e regolata da norme sempre più meticolose.
[23] “Humili genere natus” è definito da Giustino XV 4, 15.
[24] «Sic adquisito regno Sandrocottus ea tempestate, qua Seleucus futurae magnitudinis fundamenta iaciebat, Indiam possidebat, cum quo facta pactione Seleucus conpositisque in Oriente rebus in bellum Antigoni descendit» (Iust. XV 4, 20 s.)
[25] Strab. XV 2, 9: «Gli Indiani occupano parte delle terre oltre l’Indo che precedentemente appartenenvano ai Persiani: Alessandro le aveva sottratte agli Arii e vi aveva posto delle colonie. Ma Seleuco Nicatore le diede a Sandrocotto, stabilendo un trattato matrimoniale e ricevendone cinquecento elefanti» (τούτων δ' ἐκ μέρους τῶν παρὰ τὸν Ἰνδὸν ἔχουσί τινα Ἰνδοὶ πρότερον ὄντα Περσῶν, ἃ ἀφείλετο μὲν ὁ Ἀλέξανδρος τῶν Ἀριανῶν καὶ κατοικίας ἰδίας συνεστήσατο, ἔδωκε δὲ Σέλευκος ὁ Νικάτωρ Σανδροκόττῳ, συνθέμενος ἐπιγαμίαν καὶ ἀντιλαβὼν ἐλέφαντας πεντακοσίους).
[26] Tra cui alcuni potenti afrodisiaci precedentemente ignoti ai Greci, secondo Ateneo, Deipnos. I 32.
[27] «(Arsaces) cum filio eius, et ipso Theodoto, foedus ac pacem fecit, nec multo post cum Seleuco rege ad defectores persequendos veniente congressus victor fuit; quem diem Parthi exinde sollemnem velut initium libertatis observant» (Iustin. XLI 9 s.).
[28] Pag. 13.
[29] Il nome del sovrano significa letteralmente ‘senza dolore’ (da a- prefisso negativo e śoka ‘dolore’).
[30] Aśokāvadāna significa propr. ‘narrazione di Aśoka’. Si tratta di un testo del II secolo il cui valore storico effettivo è molto discutibile e discusso. Altre fonti che descrivono la vita di Aśoka sono il Divyāvadāna (“Narrazione divina”), e un testo singalese, il Mahāvaṃsa (“Grande cronaca”).
[31] PaĘaliputra è la capitale del regno di Aśoka.
[32] E’ il nome del continente del mondo terrestre.
[33] Aśokāvadāna 1.
[34] Mahāvaĕsa, 12. Dhammarakkhita ovviamente non è nome greco: il personaggio insieme con la conversione al buddhismo ha assunto un nome nuovo che indicava in modo trasparente la sua scelta religiosa (dhammarakkhita ‘fide protectus’ da dhamma e rakkhita ‘difeso, protetto’).
[35] Il dhammacakka (sanscrito dharmacakra, da dharma ‘legge morale e religiosa’ e cakra ‘ruota’) è un comune simbolo buddhista costituito da una ruota di carro con otto raggi, rappresentanti appunto le otto vie della legge.
[36] La parola designa i monaci vaganti del buddhismo, ma anche gli asceti jaina o brahmanici. Aind. śramaṇa-, pracrito samaṇa, deriva da śrama- ‘fatica, sforzo, mortificazione fisica’, a sua volta dal verbo śram- ‘stancarsi o essere stanco’; la parola è passata al tocario ṣāmaṃ, che, attraverso il tunguso šaman, è stata ripresa dal russo šaman, da cui la parola it. sciamano (e suoi corrispondenti nelle varie lingue europee).
[37] (προέστησαν δὲ ...) Ἰνδῶν τε οἱ γυμνοσοφισταί, ἄλλοι γε φιλόσοφοι βάρβαροι. διττὸν δὲ τούτων τὸ γένος, οἳ μὲν Σαρμᾶναι αὐτῶν, οἳ δὲ Βραχμᾶναι καλούμενοι. καὶ τῶν Σαρμανῶν οἱ ὑλόβιοι προσαγορευόμενοι οὔτε πόλεις οἰκοῦσιν οὔτε στέγας ἔχουσιν, δένδρων δὲ ἀμφιέννυνται φλοιοῖς καὶ ἀκρόδρυα σιτοῦνται καὶ ὕδωρ ταῖς χερσὶ πίνουσιν, οὐ γάμον, οὐ παιδοποιίαν ἴσασιν, ὥσπερ οἱ νῦν Ἐγκρατηταὶ καλούμενοι. εἰσὶ δὲ τῶν Ἰνδῶν οἱ τοῖς Βούττα πειθόμενοι παραγγέλμασιν. ὃν δι’ ὑπερβολὴν σεμνότητος ὡς θεὸν τετιμήκασι. (Clemente, Stromata, I 15, 72).
[38] E con qualche incertezza: ad esempio la distinzione tra i brāhmaṇa (Βραχμᾶνες) e i Γαρμᾶνες (sic!) è descritta in modo meno nitido, con la premessa che i contenuti delle dottrine delle due scuole differiscono poco tra di loro.
[39] Megastene (ca. 350-290), nativo della Ionia, amico di Alessandro e diplomatico al servizio prima del re Macedone poi dei Seleucidi, intrattenne rapporti con Candragupta, fu più volte in India e acquisì una conoscenza di prima mano della cultura indiana, che riassunse poi nei quattro libri di Indica, utilizzati come fonte da Strabone e da Arriano. L’edizione dei FHG di Müller riporta una quarantina di frammenti di questa opera perduta.
[40] Cfr. W.W. Tarn, p. 100. Contra, Sircar, p. 64.
[42] ὑπερβαλὼν δὲ τὸν Καύκασον καὶ κατάρας εἰς τὴν Ἰνδικήν, τήν τε φιλίαν ἀνενεώσατο τὴν πρὸς τὸν Σοφαγασῆνον τὸν βασιλέα τῶν Ἰνδῶν, καὶ λαβὼν ἐλέφαντας, ὥστε γενέσθαι τοὺς ἅπαντας εἰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντ', ἔτι δὲ σιτομετρήσας πάλιν ἐνταῦθα τὴν δύναμιν, αὐτὸς μὲν ἀνέζευξε μετὰ τῆς στρατιᾶς, Ἀνδροσθένην δὲ τὸν Κυζικηνὸν ἐπὶ τῆς ἀνακομιδῆς ἀπέλιπε τῆς γάζης τῆς ὁμολογηθείσης αὐτῷ παρὰ τοῦ βασιλέως. Διελθὼν δὲ τὴν Ἀραχωσίαν καὶ περαιωθεὶς τὸν Ἐρύμανθον ποταμόν, ἧκε διὰ τῆς Δραγγηνῆς εἰς τὴν Καρμανίαν, οὗ καὶ συνάπτοντος ἤδη τοῦ χειμῶνος ἐποιήσατο τὴν παραχειμασίαν. (Polyb. XI 34, 11-13).
[43] Secondo una tradizione raccolta nell’Aśokavadāna, Puṣyamitra intendeva distruggere lo stesso numero di santuari che Aśoka aveva edificati (ottantaquattromila), ma gli fu impedito di portare a termine questo empio progetto da parte di due yakkha (sansc. yakėa, spiriti benevoli che abitano nella profondità della terra): in questi yakkha si potrebbe anche vedere la rappresentazione di Apollodoto e Menandro I.
[44] Notiamo per incidens che quella di Puėyamitra è la prima celebrazione di questo tipo di sacrificio di cui si abbia notizia in epoca storica.
[45] Soprattutto Strabone e Giustino. Completamente perdute le opere di storici ellenistici che si erano occupati di queste vicende (qualcosa delle loro narrazioni è sopravissuto nel già citato Strabone e nelle poche allusioni di autori classici e cristiani ai re indo-greci), anche le opere dell’età successiva si presentano lacunose: ad esempio, del XLI libro di Pompeo Trogo, che esplicitamente era dedicato alle vicende di Apollodoto e Menandro, non resta che il titolo.
[46] In realtà sono state proposte date che vanno dal I sec. a.C. al III-IV sec. d.C.
[47] Questo testo, che costituisce l'ultimo capitolo (113) di un'inedita opera astrologica intitolata Vṛddhagārgasaĕhitā, si inserisce nella tradizione letteraria dei Purāṇa, testi della tradizione post-vedica destinati alla narrazione delle età del mondo. Si tratta in realtà di una storia, sia pure narrata in forma particolare, dell’impero Magadha. Sui gravi problemi di natura testuale e interpretativa posti dal testo rinviamo per più ampie informazioni a Narain, pp. 174 ss., Tarn, pp. 452-456, e soprattutto a L. Rocher, pp. 253 s. Il testo che ci è pervenuto è talmente corrotto che è stata proposta l’ipotesi che si tratti della redazione sanscrita di un’opera scritta originariamente in pracrito o in una lingua ibrida sanscrito-pracrita.
[48] ταῦτ’οὖν ἐγένετο γνώριμα ἡμῖν τῶν ἑωθινῶν τῆς Ἰνδικῆς μερῶν, ὅσα ἐντὸς τοῦ Ὑπάνιος, καὶ εἴ τινα προσιστόρησαν οἱ μετ' ἐκεῖνον περαιτέρω τοῦ Ὑπάνιος προελθόντες μέχρι τοῦ Γάγγου καὶ Παλιβόθρων («queste notizie riguardanti le parti orientali dell’India, al di là del fiume Ipani, divennero note, quando scrissero qualche rendiconto coloro che si erano spinti oltre l’Ipani fino al Gange e a Palimbroto»). Cfr. anche Strabone XI 11, 1, che, facendo riferimento ai perduti Parthica di Apollodoro Artemisio (FHG fr. 5), nomina esplicitamente le imprese di Apollodoto e di Menandro in India.
[49] Y-P 47 s. («Gli Yavana comanderanno»). La notizia dell’occupazione di Sāketa e di Mathurā ha riscontro anche in altre opere indiane (p.es. in accenni di Patañjali e di Kālidāsa). Il grammatico Patañjali, che fu contemporaneo agli avvenimenti, essendo vissuto attorno alla metà del II sec. a.C., nel suo Mahābhāėya (ad Pāṇ. 3, 2, 111: ed. Kielhorn II, p. 118) utilizza le frasi yavano ’ruṇat Sāketaṃ (“Il [principe] greco assediava Sāketa”) e yavano ’ruṇan Mādhyamikāṃ (“Il [principe] greco assediava la Terra di centro”) come esempi dell’uso sanscrito dell’imperfetto (aruṇad) per indicare un’azione che si è svolta da poco tempo. Kālidāsa nel V atto del dramma Mālavikāgnimitra ricorda un combattimento sulle rive del Sindhu, nel quale le forze dei Greci vennero debellate dall’esercito di Puėyamitra. L’episodio si sarebbe verificato proprio mentre stava transitando il cavallo che era stato scelto per l’aśvamedha. Su tutto ciò cfr. anche Weber, p. 12; Narain, p. 82 e ss.; Tarn, pp. 145 ss.
[50] Y-P 55. Ind. ārya ‘signore, uomo degno di rispetto’ è un modo formale di rivolgersi a persone di riguardo o di casta superiore, bho è un modo meno formale di salutarsi tra persone di basso rango. Con ari si intendono gli appartenenti alle tre caste superiori, con esclusione quindi dei śudra.
[51] Così risulta anche dalla documentazione epigrafica locale (nell’iscriz. di Hatigumpha, fatta redigere nel 157 dal re Kharavela di Kalinga, nella parte orientale dell’India, si afferma che questo re obbligò le armate di Demetrio, demoralizzate e prive di trasporti, a ritirarsi a Mathurā: l’iscrizione di Hatigumpha è pubblicata nel vol. XX [1929-30] di Epigraphia Indica).
[52] Y-P 56 s.: «Gli Yavana, infatuati della guerra, non resteranno nel Madhyadeśa. Ci sarà un accordo tra loro per andarsene, a causa dello scoppio di una terribile e terrificante guerra nel loro reame».
[53] «Multa tamen Eucratides bella magna virtute gessit, quibus adtritus cum obsidionem Demetrii, regis Indorum, pateretur, cum CCC militibus LX milia hostium adsiduis eruptionibus vicit. Quinto itaque mense liberatus Indiam in potestatem redegit.» (Iustin. XLI 6, 4)
[54] Tarn, p. 143; Renou-Filliozat, vol. I, p. 225.
[55] «Unde cum se reciperet, a filio, quem socium regni fecerat, in itinere interficitur, qui non dissimulato parricidio, velut hostem, non patrem interfecisset, et per sanguinem eius currum egit et corpus abici insepultum iussit» (Iustin. XLI 6, 5).
[56] Pali Sāgala, sanscrito Sākala, la Σάγαλα ἡ καὶ Εὐθυδημία di Tolomeo (Geogr. VII 1, 46) è forse l’odierna Sialkot, in Pakistan.
[57] Cfr. anche Tarn, pp. 268 e ss.
[58] Milinda è una delle forme assunta in India dal nome di Menandro (sulle monete si legge Menadra) i pañha è la forma pāli della parola che in sanscrito appare come praśna- ‘domanda’ (formata da una produttiva radice indeuropea che si ritrova nel lat. poscere e nel ted. forschen ‘cercare’).
[59] Praecepta gerendae reipublicae, 821 D: «Quando un certo Menandro, che aveva governato con benevolenza in Battria, morì in un accampamento, le città celebrarono tutte insieme il resto del funerale, poi venute in contrasto per i suoi resti a stento si accordarono che si distribuissero una parte uguale delle sue ceneri e diventassero per tutti un monumento di quell’uomo» (Μενάνδρου δέ τινος ἐν Βάκτροις ἐπιεικῶς βασιλεύσαντος εἶτ’ ἀποθανόντος ἐπὶ στρατοπέδου, τὴν μὲν ἄλλην ἐποιήσαντο κηδείαν κατὰ τὸ κοινὸν αἱ πόλεις, περὶ δὲ τῶν λειψάνων αὐτοῦ καταστάντες εἰς ἀγῶνα μόλις συνέβησαν, ὥστε νειμάμενοι μέρος ἴσον τῆς τέφρας ἀπελθεῖν, καὶ γενέσθαι μνημεῖα παρὰ πᾶσι τοῦ ἀνδρός).
[60] Yona è la forma pāli di sanscrito yavana (aind. ava > pracrito o).
[61] Mahāvaĕsa 29.
[62] I piĘaka (‘canestri’) costituiscono il canone dei libri sacri (in lingua pāli) del buddhismo. Il Milindapañha gode di notevole prestigio presso i Theravādin, la scuola buddhista che si attenne in modo rigoroso all’insegnamento del Buddha (Theravāda ‘insegnamento [vāda] degli anziani [thera, sanscrito sthavira ‘stabile, solido, vigoroso’), del quale si ritengono i fedeli garanti.
[63] Cfr. Weber, p. 12; Winternitz, v. II, p. 141; Tarn., pp. 414 ss., Boccali-Piano-Sani, pp. 99 s., e Falà, Introduzione all’ediz. italiana citata.
[64] In realtà anche per il primo libro si sospetta che alcune parti siano frutto di aggiunte posteriori.
[65] Si tratta dell’opera in cui è riportato il dialogo tra il sovrano ellenistico Tolomeo II Filadelfo (283-146) e i settantadue sapienti giudei che avrebbero tradotto in greco l’Antico Testamento.
[66] Così W.W. Tarn, pp. 414-436.
[67] Cfr. Renou-Filliozat, vol. II, p. 352 per ulteriori informazioni sull’argomento.
[68] Da Milindapañha. Le domande del re Milinda, a cura di M. A. Falà, Roma, Ubaldini, 1982.
[69] Sulle fonti cinesi cfr. Tarn, pp. 513 e s.
[70] Narain, op. cit., pag. 103.
[71] Renou-Filliozat, vol. I, p. 227.
[72] Alle opere finora citate si aggiunga la dettagliata monografia di Osmund Bopearachchi (v. Bibliografia)..
[73] Tarn, pp. 353-4.
[74] Barygaza è l’odierna Bharuch, importante porto nello stato di Gujarat, India occidentale.
[75] ἀφ’οὗ μέχρι νῦν ἐν Βαρυγάζοις παλαιαὶ προχωροῦσι δραχμαὶ, γράμμασιν Ἑλληνικοῖς ἐγκεχαραγμέναι ἐπίσημα τῶν μετ’ Ἀλέξανδρον βεβασιλευκότων Ἀπολλοδότου καὶ Μενάνδρου.
[76] Su tutto questo argomento cfr. Tarn, pp. 353.
[77] Weber, pp. 12 ss.
[78] «kesarī nāma saṃgramaę» (‘disposizione di nome “cesariana”’) nell’Avadānaśataka (‘Centuria di fatti’), uno scritto di scuola buddhista che narra fatti delle vita del Buddha e di Aśoka. Cfr. anche Weber, p. 13.
[79] Tarn, pag. 391.
[80] Per la precisione, il testo (in lingua gāndhārī e scrittura kharoṣṭhī) è il seguente: Theudorena meridarkhena pratithavida ime sarira sakamunisa bhagavato bahujanastitiye.
[81] Il testo delle due iscrizioni della colonna (generalmente molto chiaro, solamente un paio di punti dànno adito a piccoli problemi di lettura e di interpretazione) è il seguente:
«(I) Questo pilastro con Garuḍa dedicato a Vāsudeva dio tra gli dèi fu eretto da Eliodoro, un bhāgavata, figlio di Dione, di Taxila, giunto da parte del grande re greco Antalcida come ambasciatore dal re Kosiputra Bhāgabhadra il saggio nel quattordicesimo anno del suo prospero regno. (II) Tre immortali precetti se ben applicati portano al cielo: temperanza, carità, coscienza».
[82] È una delle divinità minori dell’induismo, un’aquila con piume d’oro proprietà di Viėṇu.
[83] Per un greco «la conversione all'Induismo era difficile a causa del rapporto reciproco tra la religione e il sistema castale. Un gruppo numeroso di non indù poteva essere gradualmente assimilato soltanto diventando una sotto-casta, mentre la conversione di un singolo creava il problema di fornirlo di una casta appropriata, poiché quella dipendeva dalla nascita. Era quindi più semplice per dei greci diventare buddhisti, come molti fecero. Poiché il buddhismo a quell'epoca era in fase ascendente, il suo prestigio rese l'inserimento dei nuovi convertiti molto più facile.» (Falà, pag. 11, n. 6).
[84] Weber, p. 35.
[85] La cosiddetta Chiesa di Malabar o di Kerala (sulle coste nord-occidentali dell’India) o siro-malabarica (perché il siriaco è una delle lingue liturgiche) conta oggi quattro milioni di fedeli. La storia delle comunità cristiane presenti fin da epoca molto antica sulla costa occidentale dell’India è molto complessa. La Chiesa di Malabar è una comunità cristiana che per secoli è vissuta isolata, prima della riscoperta portoghese del XVI sec.
[86] Probabilmente corruzione di un nome antico-iranico Vindafarna ‘acquista gloria’, da cui gr. υνδαφερρησ; secondo alcuni il nome sarebbe stato ripreso dalle lingue occidentali attraverso l’ulteriore corruzione armena Gaspart, da cui il nome di Gaspare (uno dei magi)!
[87] Precisamente: «Io Gesù figlio di Giuseppe il falegname concedo di acquistare il mio servo di nome Giuda a te Abbane inviato da Gundaforo re degli Indiani» (Act. Thom. 2).
[88] Attorno a questa statua (che in realtà è una statua di giada, e non di smeraldo, dell’altezza di cm. 75 e della larghezza di cm. 45) circolano racconti leggendari: dopo essere rimasta per tre secoli nella sua sede originaria dove era stata creata, la statua venne inviata a Ceylon per proteggerla da una guerra civile; alcuni secoli dopo un re straniero (birmano) chiese agli abitanti dell’isola la consegna dei libri canonici e di questa statua per potere diffondere il buddhismo nel suo paese. La nave che trasportava la statua perse la rotta e approdò in Cambogia; da qui la statua subì complicate e non sempre chiare peripezie, fino a giungere alla sua attuale sistemazione nella Cappella del Buddha di smeraldo, nei sotterranei del Palazzo Reale di Bangkok.
[89] Pag. 66.
[90] P. 135.
[91] Cfr. anche Weber, pp. 16 ss.
[92] Pisani, pag. 68.
[93] Pisani, p. 68.
[94] Aind. śruti- è una derivazione (col suffisso -ti formatore di nomi d’azione) dal verbo śru- ‘udire, ascoltare’ (gr. ἔ-κλυον ‘ascoltai’, lat. cluēns), quindi ‘il complesso di ciò che è stato udito’, e si oppone a smṛti-, che è la ‘tradizione’ (radice verbale smṛ- ‘ricordare’, la stessa che ritroviamo nel gr. μέρος ‘parte’, μοῖρα ‘destino’, ecc.).
[95] Sanscrito significa propriamente ‘perfetto’ (da sam- ‘insieme’ + kṛta-, participio passato passivo di kṛ- ‘fare’: quindi qualcosa come ‘confectus, pienamente realizzato’).
[96] Cfr. Weber, pp. 11 s.
[97] «Dicono che anche presso gli Indiani fosse cantata la poesia di Omero, avendola essi tradotta nella loro lingua: cosicché anche gli Indiani non sono in grado di vedere molte delle stelle che vediamo noi – dicono infatti che le Orse non si vedano nelle loro terre –, ma delle sofferenze di Priamo e dei lamenti e dei dolori di Andromaca e di Ecuba e del valore di Achille e di Ettore non sono inesperti: tale forza ha l’arte di un uomo!» (ὁπότε καὶ παρ’ Ἰνδοῖς φασιν ᾄδεσθαι τὴν Ὁμήρου ποίησιν, μεταλαβόντων αὐτὴν εἰς τὴν σφετέραν διάλεκτόν τε καὶ φωνήν. ὥστε καὶ Ἰνδοὶ τῶν μὲν ἄστρων τῶν παρ’ ἡμῖν πολλῶν εἰσιν ἀθέατοι· τὰς γὰρ ἄρκτους οὔ φασι φαίνεσθαι παρ’ αὐτοῖς· τῶν δὲ Πριάμου παθημάτων καὶ τῶν Ἀνδρομάχης καὶ Ἑκάβης θρήνων καὶ ὀδυρμῶν καὶ τῆς Ἀχιλλέως τε καὶ Ἕκτορος ἀνδρείας οὐκ ἀπείρως ἔχουσιν. τοσοῦτον ἴσχυσεν ἑνὸς ἀνδρὸς μουσική, Dio Chrys., orat. 53, 8)
[98] Benché la sua opera sia andata perduta e sia difficile precisare persino la lingua in cui era scritta (presumibilmente una varietà di pracrito che ebbe scarsa diffusione e una vita breve, la paiśacī), GuṇĖhavya è un personaggio pressoché leggendario in India, e in Nepal addirittura oggetto di venerazione. Una tradizione affermava che si sarebbe trattato di un genio celeste entrato in conflitto con Śiva perché avrebbe ascoltato di nascosto i racconti che questi raccontava alla moglie Pārvatī e ridotto alla condizione di essere umano.
[99] Weber, pp. 21 ss.; Pisani, p. 107.
[100] Per usare le parole di Tarn (p. 34), i Greci d’India erano «just Greeks, with all that that implies», e (p. 382) una città greca «of any pretensions without a theater is unthinkable». Non è quindi obiezione fondata il fatto che non si siano trovate tracce di anfiteatri o notizie di rappresentazioni nelle città dell’India abitate da Greci.
[101] Vita Crassi 33.
[102] Weber, p. 24 (riprendendo O. Ludwig, Dionysische Künstler, 1873, p. 104).
[103] Weber, p. 25.
[104] Secondo Hermann Reich, I ii, p. 694, il teatro indiano si sviluppò sotto l’influsso del teatro greco, ma fu il mimo, e non la commedia nuova ellenistica, a determinarne la fioritura; cfr. anche Winternitz, vol. III, p. 175.
[105] Per un’informazione generale sulla questione si veda, oltre ai testi fin qui citati, Barriedale Keith, pp. 57 ss. (con copiosa bibliografia); in generale cfr. Winternitz, vol. III, pp. 160-180 (pp. 174 ss. sull’ipotesi dell’influsso greco).
[106] “une question irritante”: Renou-Filliozat, vol. II, p. 261.
[107] Renou-Fillozat, vol. II, p. 259. Anche Tarn (pp. 383 ss.) valuta piuttosto negativamente l’ipotesi che il teatro indiano abbia preso le mosse dal teatro greco: pur non negando l’esistenza di contatti tra teatro greco e teatro indiano, afferma che contatto non significa influenza. Indubbiamente, se è sbrigativo, a nostro parere, negare un qualunque influsso del teatro greco sullo sviluppo del dramma indiano, altrettanto semplicistico sarebbe affermare che il teatro greco ebbe un peso determinante o comunque di rilievo nello sviluppo del teatro indiano. Forze endogene ed esogene possono ben coesistere: vi sono elementi chimici che generano una reazione, ma la presenza di un catalizzatore può accelerare un processo che comunque è destinato ad avvenire. Il problema allora è quello di misurare e valutare il peso e l’importanza delle forze esogene rispetto a quelle endogene: ed è lavoro di non facile soluzione!
[108] Questo disinteresse non è soltanto della storiografia antica, se Tarn poteva scrivere nel 1950, all’inizio del suo libro che «No Greek historian has yet attempted to handle this subject as a connected whole or to put it in its right place as a lost chapter of Hellenistic history» (p. xiv).
Illustrazioni: 1. Alessandro sconfigge Poro all'Idaspe (tela di Charles Le Brun, 1673, Parigi, Louvres) 2. Aśoka, poster del film realizzato in India nel 2001. 3. Il dharmacakra (pāli dhammacakka) o 'ruota della legge': da Bhubaneswar (Orissa, India), Tempio del Sole. 4. Profilo di Menandro da una moneta. 5. Monetazione tonda e quadrata realizzata in India nel periodo del Regno Indo-greco. 6. La colonna di Heliodoro nella città di Besnagar. 7. Statua di Buddha del I-II sec. d.C., in cui si colgono gli influssi della statuaria greca (Tokyo, Museo Nazionale). 8. Sakuntala e le sue amiche, tela di Raja Ravi Varma (1848–1906), conservata a Kilimanoor (Kerala).
 Cliccando
sul bottone hai
questa pagina in formato stampabile o in pdf
Cliccando
sul bottone hai
questa pagina in formato stampabile o in pdf| Per tornare alla home |
| Per contattare la Redazione |